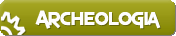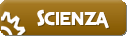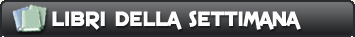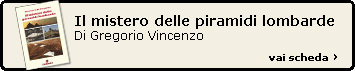Battaglia della Selva Litana, tra storia, mito e spiritualità
Il fatto storico
Nell'anno 216 l'attività dei Romani aumenta mentre decresce
quella di Annibale. Roma trova la forza di fronteggiare non solo
il nemico nell'Italia meridionale ma di inviare truppe nella settentrionale
contro i Galli. Qui però la fortuna non è favorevole
alla repubblica.
LUCIO POSTUMIO, designato console, ma non ancora entrato in carica,
guida 2 legioni composte da venticinquemila uomini nel paese dei
Boi,
legioni in Gallia Cisalpina, e ha il compito di attaccare i Celti
con l'obbiettivo di far richiamare in patria quei galli che militano
nell'esercito cartaginese.
Ma un'insidia lo attende. Lungo la via [Emilia] che deve percorrere
attraverso la vastissima Selva Litana gli alberi giganteschi sono
stati dai Galli tagliati in modo da rimanere ritti, ma ad essere
abbattuti al suolo dalla più piccola spinta, e con la selva
piena di nemici in agguato.
Quando l'esercito consolare è dentro nella foresta, cadono
con immenso fragore le piante uccidendo uomini ed animali. I superstiti,
con la strada sbarrata per la fuga, assaliti dal nemico, sono fatti
a pezzi e fra questi è Lucio Postumio.
Grande sbigottimento a Roma all'annunzio di questo nuovo disastro,
ma il Senato ordina che dalla città sia tolto ogni segno
di mestizia e di lutto. Come con fiero animo sono stati sopportati
i disastri della Trebbia, del Trasimeno e di Canne si deve con altrettanta
fermezza sopportare quello della Selva Litana. Anziché piangere
i morti è necessario intensificare la lotta contro Annibale
...
Il resoconto di Tito Livio, la battaglia degli alberi, la testa
tagliata e il tempio celtico
Nelle vaste distese boscose che occupavano un tempo il nostro territorio
non si celebravano solo riti religiosi o si svolgevano atti importanti
della vita pubblica, ma si combattevano anche sanguinose battaglie.
Queste foreste si rivelarono un valido alleato per i Galli Boi che,
diventati amici di Annibale ai tempi della seconda guerra punica,
cercavano di resistere agli invasori Romani.
Nel 218 a. C. il pretore Lucio Manlio, che marciava in soccorso
di un plotone romano assediato a Modena fu sorpreso in una selva
e ridotto così a mal partito da essere costretto a cercare
scampo nell'avamposto romano di "Tannetum" (Polibio III,
40). Dopo due anni, nel 216 a. C. fu addirittura un esercito consolare
ad essere annientato nella Silva Litana; in una vera e propria "guerra
vegetale" perse la vita il console Postumio Albino (Tito Livio,
Storie - Ab. Urb. XXIII, 24; FRONT., Strat., I, 6).
Il fatto avvenne durante l'inverno tra il 216 ed il 215 a.C. Pochi
mesi prima Annibale, capo dei Cartaginesi, aveva potuto contare
sull'alleanza di tutte le tribù celtiche della Valle Padana,
ad esclusione dei Cenomani bresciani e veronesi ed aveva inflitto
una pesantissima sconfitta ai Romani presso Canne. Questo episodio
aveva aperto la via alla ribellione di quasi tutte le tribù
celtiche che presero ad assediare Piacenza e Cremona, presidi romani.
Durante la buona stagione i Romani erano soliti effettuare delle
puntate offensive verso la Romagna allo scopo di razziare i raccolti,
i villaggi e le piccole fortificazioni collinari. Durante uno di
questi episodi, forse grazie ad una rete di false informazioni realizzata
dai Boi, circa 25 mila (secondo Livio) tra legionari ed alleati
dei Romani si addentrarono nella Silva Litana probabilmente con
la promessa di far cadere nelle loro mani bande in forza ai Cartaginesi
[Un avvenimento a metà tra storia e leggenda Gli alberi che
caddero in testa ai Romani di Alessandro Barzanti].
Quella che per i Romani fu una battaglia trappola, sarebbe avvenuta
fra Lancisa e Lizzano Pistoiese. Nella fitta selva, chiamata dai
Boi Litana o Lizana (da cui il nome Lizzano) (Sulle origini del
nome di questo paese come degli altri di cui si parlerà,
va detto che si tratta o di ipotesi riportate da autori antichi,
o di fonti storiche che sono però talvolta fra loro contrastanti.
Le derivazioni dei nomi dei paesi vengono quindi riferite tenendo
conto di questa osservazione) i Galli incisero "gentilmente"
alberi e rami dall'una e dall'altra parte della strada, in modo
non visibile e che appena si sostenessero [La strage fu effettuata
con la tecnica della "tagliata", e cioè tagliando
parzialmente gli alberi della foresta che venivano poi fatti precipitare
addosso al nemico].
"C'era una enorme foresta - racconta Livio - i Galli la chiamano
Litana, attraverso la quale Postumio Albino voleva far passare l'esercito.
Negli alberi di quella foresta, a destra e sinistra della strada,
i Galli praticarono tagli in modo che essi, se lasciati stare rimanessero
diritti, se spinti da un lieve urto cadessero. Postumio aveva due
legioni romane ed aveva arruolato dalle coste del mare un così
grande numero di alleati, che introdusse nel territorio nemico venticinquemila
armati. I Galli, si erano appostati attorno al bordo estremo della
foresta e, allorchè l'esercito entrò nella selva,
diedero una spinta agli ultimi alberi tagliati. Questi crollarono
l'uno sull'altro, abbattendosi giù dai due lati e seppellirono
armi, uomini, cavalli; scamparono a mala pena dieci uomini. I più
furono uccisi dai tronchi degli alberi e dai rami spezzati; i Galli
che erano appostati tutti intorno alla selva, massacrarono la massa
rimanente in preda allo scompiglio a causa dell'imboscata, pochi
furono catturati mentre cercavano di raggiungere un ponte sul fiume
precedentemente occupato dai nemici. Qui Postumio cadde lottando
con ogni forza per non essere preso. I Boi festanti portarono le
sue spoglie e la sua testa tagliata nel tempio, che presso di loro
era più sacro. Ripulita poi la testa come è loro costume,
ornarono il teschio con un cerchio d'oro, e questo era per loro
un vaso sacro con cui libare alle solennità, e allo stesso
tempo una coppa per i pontefici e per i sacerdoti del tempio e,
agli occhi dei Galli, il bottino fu non minore della vittoria".
[24] ... Silua erat uasta- Litanam Galli uocabant- qua exercitum
traducturus erat. Eius siluae dextra laeuaque circa uiam Galli arbores
ita inciderunt ut immotae starent, momento leui impulsae occiderent.
Legiones duas Romanas habebat Postumius, sociumque ab supero mari
tantum conscripserat ut uiginti quinque milia armatorum in agros
hostium induxerit. Galli oram extremae siluae cum circumsedissent,
ubi intrauit agmen saltum, tum extremas arborum succisarum impellunt;
quae alia in aliam, instabilem per se ac male haerentem, incidentes
ancipiti strage arma, uiros, equos obruerunt, ut uix decem homines
effugerent. Nam cum exanimati plerique essent arborum truncis fragmentisque
ramorum, ceteram multitudinem inopinato malo trepidam Galli saltum
omnem armati circumsedentes interfecerunt paucis e tanto numero
captis, qui pontem fluminis petentes obsesso ante ab hostibus ponte
interclusi sunt. Ibi Postumius omni ui ne caperetur dimicans occubuit.
Spolia corporis caputque praecisum ducis Boii ouantes templo quod
sanctissimum est apud eos intulere. Purgato inde capite, ut mos
iis est, caluam auro caelauere, idque sacrum uas iis erat quo sollemnibus
libarent poculumque idem sacerdoti esset ac templi antistitibus.
Praeda quoque haud minor Gallis quam uictoria fuit; nam etsi magna
pars animalium strage siluae oppressa erat, tamen ceterae res, quia
nihil dissipatum fuga est, stratae per omnem iacentis agminis ordinem
inuentae sunt.
Dunque Tito Livio descrive la morte del proconsole Lucio Albino
Postumio, e sappiamo che il cranio del romano fu ripulito e svuotato,
come la zucca di Ognissanti, per adempiere, previa doratura, alla
nobile funzione di vaso sacro. Dunque il cranio del console ucciso
nel fatto d'arme, ricoperto di lamine d'oro, venne conservato in
un tempio della Bologna gallica per servire alle libagioni rituali
dei sacerdoti. Ovvero dei DRUIDI.
Questo rito veniva riservato solo ai nemici particolarmente valorosi
e serviva per volgere i loro passati poteri a favore dei vincitori.
"Anche la saga irlandese di Cù Chulainn fa riferimento
a questo rituale, quando descrive il castello del re Conchobar,
in cui un vasto locale era adibito all'esposizione delle teste tagliate.
Lo stesso Cù Chulainn, nel racconto irlandese del Festino
di Bricriu, deve tagliare la testa del gigante Uath. Sempre nel
Mabinogion, Bran il Benedetto, ferito a morte, viene decapitato,
su sua stessa richiesta, e la reliquia proteggerà i compagni
sopravvissuti per sette anni, fino alla sepoltura sulla Bianca Collina
di Londra: secondo la tradizione, il miracoloso cranio difenderà
la città dalle invasioni, finché sarà dissepolto
da Artù. In Sir Gawain e il Cavaliere Verde, straordinario
romanzo medioevale inglese, il tema della decapitazione, tratto
dagli antichi miti dei Celti, diventa occasione di profonde rivelazioni
metafisiche.Le Teste Tagliate, verosimilmente, rappresentano il
prezioso contenitore di un'energia misteriosa, soprannaturale, che
può mettere in comunicazione il mondo visibile con quello
invisibile e il rituale druidico, ad esse collegato, non fa che
elevare alla sfera del Sacro tutti gli esseri che vi partecipano.
Altroché una barbara usanza! Numerose testimonianze archeologiche
confermano l'uso sacrale dei crani da parte dei Celti. Nell'oppidum
celto-ligure di Entremont (Aix-en-Provence), nel Sud della Francia,
capitale e, al tempo stesso, santuario dei Salii, sono stati ritrovati
dei pilastri in pietra calcarea, con il rilievo di dodici crani:
essi facevano parte della "Sala delle teste", distrutta,
insieme al santuario, dai Romani che temevano quel luogo sacro,
in quanto potenziale centro di una futura rivolta. A Roquepertuse,
sempre in Provenza, tre pilastri in pietra, in origine policromi,
reggevano un portale con nicchie per esporre le teste umane"
[Quando il nemico perde la testa, di Alina Mestriner Benassi].
I Celti tagliavano le teste, sì, ma solo quelle di alcuni
capi, dopo la loro morte, o quelle dei nemici uccisi, che volevano
onorare, e le inchiodavano alle porte delle case e dei santuari.
Abbiamo notizia di questo rituale da Diodoro Siculo e da Strabone,
che ebbero, come fonte, Posidonio di Apamea, filosofo stoico che
scrisse anche una Storia universale, della quale non ci è
pervenuto quasi nulla. Ricordiamo anche la preziosa falera di Manerbio,
che raffigura un triskell contornato da teste tagliate, ed è
divenuta il simbolo dell'associazione Gallia Cisalpina.
La sconfitta è ricordata anche da SEXTVS IVLIVS FRONTINVS
in Strategemata Liber Pimus, 6:
Boii in silva Litana, quam transiturus erat noster exercitus, succiderunt
arbores ita, ut parte exigua sustentatae starent, donec impellerentur;
delitueruntdeinde ad extremas ipsi ingressoque silvam hoste <per>
proximas ulteriores impulerunt: eo modo propagata pariter supra
Romanos ruina magnam manum eliserunt.
La Selva Litana
Fino ad ora questa Silva Litana non era stata ben individuata ed
alcuni studiosi credevano di poterla collocare vicino a Modena.
Un giovane ricercatore reggiano, Nicola Cassone, ha ipotizzato recentemente
che questa battaglia sia stata combattuta proprio vicino a Reggio
e porta a convalidare la sua tesi una serie di prove inconfutabili.
Secondo lo studioso di storia romana, Tacito nel 69 d. C., in occasione
della morte dell'imperatore Otone, parla di un uccello visto apparire
in un bosco presso Reggio, che lì rimase fino al giorno in
cui l'imperatore non si tolse la vita nel suo accampamento presso
Brescello. I1 bosco citato da Tacito sarebbe quello sacro dei Galli
Boi, la Silva Litana insomma; il tempio "Fanum" è
stato in seguito individuato tra S. Polo e Montecchio. Secondo Cassone
il nome Litana deriverebbe da Litabos (sacro, consacrato) per cui
non dovrebbero esserci dubbi che la battaglia, dove perse la vita
Postumio Albino con le sue legioni, è proprio collocabile
in provincia di Reggio. "Apud Regium" scrive Tacito e
cioè nei pressi di Reggio, in un "celebre bosco sacro"
e quale se non quello sacro ai Galli?.
http://www.giramondo.com/n9911/storia08.htm
Ha poi stabilito un interessantissimo collegamento tra la figura
di San Donnino e il culto celtico delle teste tagliate, particolarmente
significativo in Emilia, nela Selva Litana, tra iBoi.
Quasi che il culto di questo santo sia una sopravvivenza dell'antico
culto celtico.
Ipotesi suggestiva e veramente ispirata, degna di riflessione.
Donnino era un martire cristiano morto durante le persecuzioni di
un imperatore romano nel 304 d.C. circa. Era un giovane cavaliere
al servizio dell'imperatore, che fu costretto a fuggire da Milano
dopo che venne scoperto che era cristiano; a Firenze fu raggiunto
e ucciso (gli fu tagliata la testa con una spada). La leggenda narra
che il cavaliere raccolse la propria testa e la depositò
nel luogo dove ebbe la sepoltura.
Dunque il martire cristiano che sullo Stirone, poco prima dell'ingresso
in città, venne decapitato e miracolosamente riuscì
ad attraversare il torrente, con la testa in mano, salvando il proprio
corpo dall'ira dei legionari dell'imperatore Massimiano (che applicava
l'editto di Diocleziano contro i cristiani).
Pensando al toponimo del fiume, Stirone, Cassone rileva come esso
abbia una indiscutibile assonanza con la Dea celtica Sirona, dett
anche Tsirona o Stirona (!), che significa stella (in una raffigurazione
porta sulla testa una falce lunare), e viene definita come "dea
del cielo notturno e quindi del 'lato oscuro della vita' e dell'aldilà"
Mitologia celtica di S. e P: Botheroyd. Proprio il uogo di passaggio
del santo, e anche Postumio passò su un fiume di una zona
non lontan. La cosa strana poi è che molti edifici sacri
sono posti vicino afiumi che hanno la stesssa radice str, e in Provenza
(dove il culto delle teste tagliate è attestato in forma
notissima, si pensi a quelle statutarie rinvenute nelll'oppidum
celtico di Entremont, che ho visto di persona) l'edifico dedicato
al santo è a Sisteron!
Tutti i martiri sono raffigurati con lo strumento del loro martirio,
quindi San Donnino è raffigurato con la spada, che è
anche il simbolo del suo stato di cavaliere.
Va ricordata la vasta diffusione della devozione per il Santo, che
iniziata nel luogo della sua sepoltura - la necropoli dell'antica
Flavia Fidentia, sulla quale sorse nel Medioevo un nuovo Borgo che
da lui prese nome (Borgo San Donnino, rinominato Fidenza nel 1927)
- s'irradiò attraverso gli itinerari di pellegrinaggio in
circa 80 località della Lombardia e della Toscana - intese
nell'estensione politico-geografica medievale, cioè nelle
attuali Lombardia, Emilia, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche -
dove ancora oggi sono documentate le dedicazioni d'edifici sacri
o d'altari, con le relative immagini, sino a raggiungere addirittura
l'alta Provenza, nella chiesa di S. Donnino di Sisteron.
Dalla selva incisa, in antico ancisa, trasse origine il nome l'Ancisa,
divenuto poi Lancisa. Secondo altre fonti riportate da Emanuele
Repetti, la Litana Siva, località della battaglia, sarebbe
situata in una zona imprecisata dell'Emilia. Il Cini, che scrisse
un secolo prima del Repetti, aveva invece esclusoche la Litana Siva
fosse in Emilia ( Litana Silva. La versione di alcuni storici contemporanei
è che la Litana Silva fosse in Emilia, probabilmente nei
pressi di Cento. Essi riferiscono che i Galli Boi vi sconfissero
l'esercito di Lucio Postumio nel 216 a.C., e visi rifugiarono nel
196 a.C. di fronte all'avanzata di Marco Claudio Marcello e di Lucio
Furio Purpureone).
La Selva Litana sarebbe stata attraversata anche da Giulio Cesare.
Ai tempi di Cesare però gran parte di questa selva era stata
abbattuta; si dice tuttavia che nella parte rimasta Cesare si era
smarrito. Gambettola è ancora oggi conosciuta con il suo
vecchio nome di "BOSCO". Proseguendo verso San Mauro (che
allora non esisteva come centro abitato), Cesare pare si sia fermato
in preghiera presso il locale tempio di Giove (più tardi
corte Jovedia) probabilmente nei pressi della Torre. Secondo gli
storici la Selva Litana era compresa tra il Rubicone e il Po e i
lavori di disboscamento, necessari per l'apertura della via Emilia
(in epoca romana) ne avrebbero, nella nostra zona, provocato il
frazionamento nelle boscaglie di Gazo (oggi Ribano) e Gualdo. C'è
chi sostiene che l'antichissimo bosco si estendeva parallelamente
all'asse della via Emilia, tra questa e lo stagno Padusa (questo
stagno era una vasta palude di cui non c'è più traccia,
scomparsa forse in seguito alle opere di bonifica romana). Lo stagno
Padusa era compreso tra il litorale adriatico e il limite della
terra ferma a partire dalla foce dell'Uso (che si trova tra il territorio
di San Mauro e San Vita) fino al Po.
Sulla localizzazione della Silva Litana tuttavia non c'è
certezza assoluta, tanto che gli storici romagnoli dal 1500 al 1800
fecero a gara per attribuire alla propria città l'antica
posizione della foresta. Anselmo Calvetti, sulla base di alcune
considerazioni approfondite nel suo libro Celti in Romagna edito
da Longo di Ravenna, ritiene che il luogo destinato all'insidia
non poteva essere né troppo vicino alla piazzaforte boica
di Bologna, pena un assalto in massa, né ad oriente del Savio,
in quanto dalle posizioni difensive di Rimini e di Sarsina le forze
romane avrebbero impedito il transito di bande armate sia lungo
la costa adriatica che verso il Casentino. Perciò è
possibile "circoscrivere la battaglia - afferma Calvetti -
in una delle vallate dell'Appennino romagnolo tra il Ronco-Bidente
e il Santerno. Tra queste vallate si prestava meglio all'agguato
quella del Montone ovvero quella del Lamone, strette e tortuose
entrambe".
Belenus (Bel o Belenos o Belinus) Beleno (Belin)
Belenos = lo splendore, il pulito, il dio del sole (Galli) Epiteto
dell'Apollo dei Galli. Il Dio è collegato al fuoco come elemento
trasformatore. Dio della luce, protettore delle pecore e del bestiame.
Sua sposa è la dea Belisama. Sono figure assimilabili alle
divinità classiche Apollo e Minerva. Assimilabile al Dio
irlandese Lugh, e al Dio Gallese Llew.
Beleno (Belin) è il Dio solare e luminoso, protettore delle
pecore e del bestiame, ed è ritenuto uno degli antichi dei
celtici più diffusi in Europa. Il poeta gallo-romano Ausonio
di Bordeaux nel VI sec d. c. afferma che anche a Bordeaux, oltre
che ad Aquileia e in altre zone d'Europa, c'era un tempio dedicato
al Dio Beleno.
BELISAMA o Belasama (Britanni) è invece la dea "molto
brillante", epiteto dato alla Minerva gallica. Dea del fiume
Ribble presso le tribù britanne. Sposa di Beleno. Belisama
= la dea splendente, la luna.
Beltine è una parola celtica e significa "fuoco"
e viene collegata al dio Beleno, venerato nella Gallia sud-orientale,
in Italia settentrionale, nel Norico. In Friuli è stata chiaramente
individuata: sono state contate 54 epigrafi scoperte in Aquileia
[vedi ] e dedicate al dio Beleno (I-III secolo dell'impero), altre
epigrafi sono state rinvenute a Barbana, nella Laguna di Grado,
a Concordia e a Zuglio in Carnia.
(Tratto da: Tito Maniacco, Storia del Friuli, Newton Compton editori,
1985)
La festa di Beleno.
è una delle quattro feste dell'anno celtico e si svolge il
1° maggio. Significa letteralmente "fuoco di Bel".
In questo giorno giunsero i diversi invasori dell'Irlanda, secondo
le cinque invasioni descritte nel Libro delle Conquiste. La festa
è carica di simbolismi solari e ignei. In questo giorno venivano
bruciati i fantocci antropomorfi in vimini pieni di vittime umane.
Esso segna l'inizio del ciclo diurno e solare, il momento in cui
il bestiame si avvia al pascolo. è parimenti una festa sacerdotale
della massima importanza, in cui il re supremo d'Irlanda riaccendeva
il fuoco sacro insieme ai suoi druidi e che veniva festeggiata con
giochi e banchetti. Chi avesse osato riaccendere il fuoco prima
del re sarebbe morto immediatamente, cosa che san Patrizio fece
impunemente, determinando così molti a convertirsi al cristianesimo.
Beltane (la notte che, convenzionalmente, precede l'alba del il
1° Maggio) è la festa dedicata al "Fuoco di Bel"
come dice il nome, che richiama il Belenus Gallico, dio della Luce,
segna la fine dell'Inverno e l'inizio dell'estate. Con l'annuncio
della buona stagione, Beltane, per un popolo guerriero come i Celti,
segnava anche l'inizio delle scorrerie e delle glorie d'armi.
http://www.keltia.it/testi/celti/tempotx.htm
Beleno ad Aquileia
Beleno è una divinità panceltica, il cui culto è
sempre associato alle acque, ai complessi termali, alle pratiche
di medicina e all'oracolo. Beleno è il dio della rinascita.
Esiste un profondo legame tra Aquileia e il culto di Beleno, tanto
che si può affermare che questa doveva essere la principale
divinità aquileiese. Tra l'altro Aquileia non era nuova a
sincretismi culturali, data la sua posizione chiave - fin dall'epoca
preistorica - nel crocevia tra l'area altoadriatica ed il mondo
norico, retico, pannonico, danubiano.
Nel 238 d.C. i soldati dell'imperatore Massimino cingono d'assedio
Aquileia: la città è stremata ma non cede. Ascoltiamo
il racconto di Erodiano:
Questo si diceva del resto all'inizio della guerra: che [gli aquileiesi]
erano rimasti fedeli perché dentro la città c'erano
molti che si occupavano dell'altare del sacrificio ed erano esperti
di lettura del fegato, e annunciavano i sacri auspici; gli italiani
infatti credono moltissimo in questo tipo di indagine. E diversi
responsi dicevano che il dio protettore della terra prometteva la
vittoria. Chiamano questo [dio] Beleno, e lo venerano grandemente;
pretendendo che sia Apollo. Dicevano alcuni dei soldati di Massimino
che la sua immagine era apparsa spesso nell'aria combattendo sopra
la città.
Un'altra fonte riporta una versione simile:
Assediando dunque Aquileia, Massimino mandò ambasciatori
in quella città: ai quali il popolo forse avrebbe dato retta,
se non si fossero opposti Menofilio e l'altro console, dicendo anche
che il dio Beleno per bocca degli aruspici aveva risposto che Massimino
doveva essere sconfitto. Per cui si dice che anche dopo i soldati
di Massimino si vantavano che Apollo doveva aver preso le armi contro
di loro, e che quella non era stata la vittoria di Massimo o del
senato, ma la vittoria degli dèi.
Il culto di Beleno pare attestato sino al VI secolo dopo Cristo
in area aquileiese. E' un dio legato all'acqua e al tema della rinascita:
e il culto in area aquileiese di San Giovanni Battista, attestato
anteriormente all'anno 390, può forse essere considerato
una derivazione sincretistica di quello del dio celtico. Beleno
è inoltre il dio della luce, del sole, della conoscenza,
come Apollo. Ma anche come Mithra o Cristo, ambedue ben presenti
nel mondo aquileiese.
Dunque nel 238 d.C. vi fu la difesa di Aquileia dall'assedio di
Massimino il Trace, imperatore barbaro eletto in campo di Marte.
In Aquileia infatti viveva la resistenza fedele al Senato romano
e per 22 giorni l'impetuosità e la forza fisica dei Celto-Karni
affiora in città tanto che i cittadini resistono al forte
esercito di Massimino. Erodiano racconta che il dio Beleno era stato
visto combattere sulle mura insieme ai suoi devoti.
Il culto del dio Beleno era da secoli il fulcro della religiosità
dei Karni, assiema ad un nutrito pantheon di divinità che
sempre hanno contraddistinto la vita mistica dei popoli celtici.
Beleno (Belin) è il dio solare e luminoso ed è ritenuto
uno degli antichi dei celtici più diffusi in Europa. Il poeta
gallo-romano Ausonio di Bordeaux nel VI sec d. c. afferma che anche
a Bordeaux, oltre che ad Aquileia e in altre zone d'Europa, c'era
un tempio dedicato al dio Beleno. I Romani lo paragonavano ad Apollo.
Nella Carnia era molto radicato anche il culto del dio Ogmios, il
dio che guida le anime nell'aldilà, il dio campione; esso
raffigura l'aspetto oscuro della divinità suprema e dai Romani
venne identificato con Ercole, come colui che interviene in prima
persona nelle vicende dei Celti rendendo sicura la via delle Alpi.
297-297 d.C. Soggiorno di Diocleziano e Massimiano, che offrono
dediche al dio Beleno, nume tutelare di Aquileia.
Questo periodo è legato all'ultima persecuzione contro i
cristiani, che fu a lungo ricordata perche' diede dei martiri anche
in Aquileia nel 303-305. La presenza degli Augusti segna l'ultimo
atto di venerazione a Beleno, che si inginocchiarono di fronte al
Dio celtico, in antitesi al cristianesimo ed in omaggio al culto
tradizionale.
Il dio solare diventa Belinus Augustus, il nume tutelare di Aquileia.
(Non si tratta di un caso raro: nell'olimpo di Roma trovarono posto
gli dei egiziani ed etruschi).
Sciamanesimo celtico
Aspetti generali
Nel druidismo e più in generale nel complesso delle credenze
celtiche si sono ravvisati elementi sciamanici. Più volte
è stato citato questo aspetto della civiltà celtica,
tuttavia è indubbio che sia difficile trovare riscontri storici.
Occorre quindi allargare l'indagine in ambiti più ampi di
quelli normalmente studiati.
Quando si parla di sciamanismo non si può non partire dal
testo di Mircea Eliade "Le sciamanisme", che a tutt'oggi
resta una sorta di Bibbia sull'argomento. Eliade ribadì che
lo sciamano non è uno stregone, un sacerdote, un "medicineman"
o un "curandero": lo sciamano è anche questo, tuttavia,
non è solo questo. Egli è essenzialmente una persona
(uomo o donna) che padroneggia la tecnica dell'estasi. Lo sciamano
è l'unico in .grado di recarsi nell'aldilà, cioè
nel mondo degli spiriti, per combatterli e ottenere dei benefici
per i singoli o per la comunità. Le tecniche per far questo
sono essenzialmente il sonno estatico e la trasformazione in animale
del proprio spirito
Lo sciamano è un predestinato per nascita o per scelta di
altri sciamani, ma non è mai un posseduto. Ciò che
lo distingue da questi e dagli estatici è il rapporto che
si instaura con gli spiriti: mentre i posseduti vengono impadroniti
da esseri magico-demoniaci, lo sciamano "... domina i suoi
spiriti" nel senso che lui, essere umano, riesce a comunicare
con i morti, con i demoni, con gli spiriti della natura, senza per
questo trasformarsi in un loro strumento." Questa introduzione
forzatamente superficiale allo sciamanismo tratteggia alcuni aspetti
importanti relativi al nostro campo di indagine. Fra i tanti caratteri
dello sciamanismo vorrei sottolineare alcuni che posso riferirsi
al mondo celtico: la trasformazione zoomorfica, gli animali psicopompi,
il sonno estatico e. il rapporto con l'aldilà.
La zoomorfosi si trova già nei miti celtici più antichi.
Tuan, figlio di Carell, si trasforma in cervo, in cinghiale e in
falco "sempre nel medesimo luogo". Gwyon Bach, per sfuggire
Keridwen che lo insegue, si trasforma in lepre, in pesce, in uccello
e infine in chicco di grano. Keridwen si trasforma a sua volta in
levriero, lontra, rapace e gallina, che mangia il chicco restando
incinta di Gwyon. Dopo nove mesi partorirà un bimbo che sarà
il. bardo Taliesin.
Cosa hanno a che vedere questi due miti con lo sciamanismo? Innanzitutto
il fatto che gli animali in cui si trasformano gli eroi sono esseri
simbolici profondamente legati all'aldilà. Il cervo, per
esempio, (come pure il cinghiale) è l'animale psicopompo
per eccellenza. E' lui che nel corso di cacce, in cui l'eroe si
perde nei boschi, lo porta a vivere avventure in un regno precluso
a tutti, da cui egli ritorna dopo aver compiuto particolari imprese.
(...)
da Revue d'Historie Celtique
http://www.celti.it/revue/revue8.htm
Sciamanesimo celtico e i cani
Nella cultura celtica il cane ha sempre avuto un ruolo preminente
("molto importante, ... tanto che nel citare i beni di un re
non veniva mai a mancar eun cane" Taraglio, Il vischio e la
Quercia, 2001, p. 336, dove c'è un'ottima sintesi dei significati
del cane nella cultura celtica), nelle due varianti del cane domestico
e del cane selvaggio, il lupo.
Partiamo dai tempi più recenti, per tornare a ritroso fino
ai celti più antichi.
"Ciò che caratterizza Merlino, come pure il suo equivalente,
il Daga irlandese, è di essere padrone degli animali. Nella
Vita Merlini .. lo si vede accompagnato da un lupo, vale a dire
che è un lupo. Essere padrone degli animali è infatti
non soltanto farsi obbedire dagli animali, ma ugualmente poter rivestire
le forme animali. E questo è sciamanesimo puro.
... si sa che i druidi, alla guisa degli sciamani, portavano spesso
pelli di animali e copricapi ornati di corna (... il famoso druido
Mog Ruith si fa portare la sua pelel di toro e un copricapo a forma
di uccello) ... Nella Vulgata, quando esce dalla foresta come Uomo
Selvaggio, Merlino è rivestito di una pelle di lupo... nella
Vita Merlini è precisato che ... durante l'estate errerà
nei boschi in compagnia di un lupo grigio" [Jean Markale, Il
druidismo, Paris 1985, 1a ed. It. Roma 1991, Mondadori Milano 1994,
2001, p. 247 e 251]
Presso gli antichi Celti, dove il cane è associato al mondo
dei guerrieri, paragonare un eroe ad un cane significava celebrarlo
e rendergli grande omaggio.
Caro ai guerrieri era il cane, in particolare per il valido aiuto
che offre nella caccia, ma anche per il suo ruolo affine a quelle
del guerriero di protettore della comunità, che esercita
facendo la guardia.Si deve ricordare che anche la caccia , e così
la guerra, erano per i Celti attività sacre , che si potevano
svolgere solo dopo un apprendistato di tipo iniziatico .Nella mitologia
Irlandese poi il cane Dormarth è posto alla guardia del regno
dei morti e ciò lo apparenta al cerbero della mitologia classica
, ma per "l'elasticità" dell'Oltretomba celtico
non è altrettanto accentuato l'aspetto mostruoso e demoniaco.
http://spazioinwind.iol.it/ilboscodiarafel/druidianimal.html
Il cane possiede "un simbolismo composito" (Miranda Green),
è associato:
1) alla salute: i Celti credevano che per guarire da certe malattie
bastasse applicare la saliva canina.
2) alla caccia: il cane seguiva i cacciatori li aiutava a scovare
le prede e li proteggeva
3) alla morte: il Dio del mondo sotterraneo era accompagnato da
cani bianchi con le orecchie rosse [il Dio gallese dell'oltretomba
Arawan ha una muta di tali cani, cfr. Mabinogi, i Cwn Annwn, o Cani
di Annwn, annunciatori di morte].
http://digilander.libero.it/dunkelorg/art9.htm
Il cane è importante nella mitologia celtica e appare frequentemente
con gli Dei-cacciatori, come Sucellos, il 'Buon Colpitore', e con
la Dea cavalla Epona. I cani erano associati con le acque risanatrici
e Nodens, Dio della Guarigione, poteva manifestarsi in forma id
cane. I cani sono anche animali psichici, sono connessi con la divinazione
e sono frequentemente persone che hanno subito metamorfosi nel folklore
celtico. Vi sono infiniti resoconti di fantasmatici, sovranaturali
o incantati cani che possono essere favorevoli o malevolenti [Cooper,
J. C. - SYMBOLIC & MYTHOLOGICAL ANIMALS Aquarian/ Thorsons London
1992).
Aweniti e Imbas Forosnai
Giraldus Cambrensis (c. 1147 - c. 1223) menziona nella sua Description
of Wales una classe di persone chiamate Awenithion, e che sembrano
praticare un'arte strettamente imparentata con quella descritta
per l'Irlanda druidica dal Glossario di Cormac come imbas forosnai
(scienza che illumina, in base alla quale il file-bardo mastica.
carne di maiale rosso, di cane o di gatto e in seguito depone il
pezzo masticato su una pietra piatta dietro un'entrata, e lo offre
agli Dei con un incantesimo, invocandoli ripetutamente. Se l'indomani
il pezzo è sparito, "incanta le sue due palme e se le
tiene sulle guance finchè non si addormenta. Poi lo vegliano,
affinchè egli non sia infastidito o turbato prima che tutto
gli venga rivelato.." e in tal modo accede alla conoscenza
del futuro).
'Sunt et in hoc Kambriae populo quod alibi non reperies, viri nonnulli,
quos Awennithion vocant, quasi mente ductos. Hi super aliquo consulti
ambiguo stsim frementes spiritu quasi extra se rapiuntur, et tanquam
arrepti fiunt. Nec incontinenti tamen quod desideratur edisserunt
; sed per ambages multas, inter varios quibus effuunt sermones nugatorios
magis et vanos quam sibi coherentes, sed omnes tamenornatos, in
aliquo demum verbi diverticulo qui responsumsolerter, observat quod
petit accipiet enucleatum. Et sic denique de hac extasi tanquam
a somno gravi ab aliisexciantur, et quasi per violentiam quandam
ad se reverticompelluntur. Ubi et duo notanda reperies ; quia post
responsum, nisi violenter excitati et revocati, ab hujuscemondi
quasi furore reverti non solent, et quod in se reversi, nihil horum
omnium, qua ab his interim prolata sunt, ad memoriam revocabunt.
(unde et, si forte super hoc iterum vel alio consulti dicere debeant,
aliis omnino verbis et alienis enantiabunt ; ) forsan sicut per
phanaticos et emergumenos spiritus interdum loquuntur, quanuam ignaros.
Solent autem eis haec dona plerumque in somnis per visiones infundi.
Quibusdam enim videtur, quod eis schedula inscripta ori imponatur.
Et statim a somno erecti et conori effecti, se gratiam hanc suscepisse
publice profitentur.'
'There are certain persons in Cambria...called Awenyddion, or people
inspired; when consulted upon any doubtful event, they roar out
violently, are rendered beside themselves, and become, as it where,
possessed by a spirit. They do not deliver the answer to what is
required in a coherent manner; but the person who skilfully observes
them will find, after many preambles... The desired explanation
conveyed in some turn of a word: They are then roused from their
ecstasy, as from a deep sleep, and, as it where, by violence compelled
to return to their proper senses. After having answered the questions,
they do not recover until violently shaken by other people; nor
can they remember the replies they have given...These gifts are
usually conferred upon them in dreams: some seem to have sweet milk
or honey poured on their lips; others fancy that a written schedule
is applied to their lips, and on awakening they publicly declare
that they have received this gift.'
The Journey Through Wales / the Description of Wales. Geraldus Cambrensis
Trans. L. Thorpe 1978 Book1 Ch 16 (translation citation courtesy
of Ken waldron)
I Druidi - Maghi dell'Occidente
In Ulster nessun uomo parlava prima del Re Conchobar, e il Re Conchobar
non poteva parlare prima dei tre druidi.
(La razzia del Bestiame di Cooley)
Nei tempi antichi, molti differenti capi tribali, re e regine regnavano
sulle terre che noi oggi pensiamo Celtiche. Ma i Druidi erano quasi
tanto potenti quanto questi governanti. Nei tempi antichi questi
Druidi erano maschi e femmine.
Così chi erano questi uomini e donne le cui voci erano sentite
prima di quelle dei loro re?
Chi erano i primi Druidi e quando la pratica del Druidismo cominciò?
Nessuno lo sa. La nozione più romantica è che i Druidi
erano i maghi di Atlantide.
Quando Atlantide venne sommersa dalle onde, essi presero le barche
e andarono a Ovest in America e ad Est verso le coste di Irlanda
e Britannia.
Questo permette di spiegare perchè molto della pratica druidica
è simile alla pratica dei nativi d'America.
Entrambi creavano circoli sacri, onoravano le direzioni, e avevano
una profonda riverenza per il mondo naturale.
Entrambi credevano negli animali guida, e confidavano in modo sensibile
nel fatto che la terra è sacra.
Come i Nativi Americani, i Druidi usavano Capanne sudatorie, che
sono simili a saune, e usavano le piume degli uccelli nell'abbigliamento
derimoniale e comecopricapi. E avevano una grande quantità
di conoscenze su alberi, erbe, piante e animali, e una meravigliosa
collezione di miti e storie.
Ma forse essi non hanno la stessa origine in Atlantide, forse Atlantide
non è mai esistita.
Le similitudini tra i druidi e molte tradizioni indigene può
essere spiegata con il fatto che esse hanno tutte preso contatto
con gli stessi principi spirituali che esistono nel mondo archetipo,
spirituale.
Se il Druidismo sia o meno iniziato in Atlantide molte migliaia
di anni fa, noi non lo sapremo mai per certo, ma ciò di cui
noi possiamo essere certi, è che lentamente le pratiche spirituali
si siano evolute in Europa a partire dalla devozione verso un certo
numero di divinità, con molti esperti che ora privilegiano
il punto di vista che la principale tra queste era una Divinità
(Dea) della Natura (Philip Carr Gomm).
La continuità storica del Druidismo attraverso i Bardi
del Galles
E' interessante mettere in evidenza quanto molti, che ostinatamente
ignorano (o non conoscono) le fonti storiche a nostra disposizione,
rifiutano per ingiustificato pregiudizio: ovvero che vi sono elementi
forti di continuità storica tra il druidismo antico e quello
moderno.
In realtà per quanto riguarda i bardi [che sono la funzione
dei druidi che è riuscita a sfuggire alla persecuzione cristiana
perchè oltre che incantatori erano anche poeti e musicisti,
e hanno mantenuto la loro dottrina druidica sotto una superficiale
riverniciatura cristiana] esiste, in Galles, una continuità
storica ininterrotta, e addirittura documenti filosofici come le
triadi bardiche o Barddas che ci forniscono preziosi elementi per
poter consentire ai più seri ordini druidici esistenti (in
Bretagna e Inghilterra, e tutti seguaci del rito gallese) di poter
praticare in modo serio e coscienzioso il druidismo.
Ecco on line il testo della Barddas (che sotto una superficiale
forma a volte cristiana rivelano autentico pensiero panteistico
e anche direttamente pagano, come nella triplice ripartizione dei
precetti conformemente alla triplice ripartizione funzionale delle
antiche società indoeuropee)
http://www.summerlands.com/crossroads/library/slideviewer/barddas.html
Questi testi, Barddas, sono scritti in gallese e compilati nel XVI
secolo dal bardo e studioso gallese Llewellyn Sion di Glamorgan.
Secondo il noto studioso irlandese Thomas William Hazen Rolleston
(nella sua opera I miti celtici, Tea ediz. P. 298)
"l'ordine dei bardi possedeva senza dubbio una Dottrina del
genere. Quell'ordine fu presente nel Galles con una certa continuita'.
E anche se nessun critico si fiderebbe mai a costruire la teoria
di una dottrina precristiana basandosi su un documento del XVI secolo,
non sembra tuttavia saggio scartare completamente la possibilità
che alcuni frammenti di antiche credenze possano essere sopravvisuti
nella tradizione bardica fino ad un'epoca così recente".
Aggiunge Rolleston, il cui testo è una fonte fondamentale
e affidabilissima per lo studio della mitologia celtica, che "in
ogni caso i Barddas sono un'opera di interesse filosofico notevole,
e se anche rappresentassero solo una particolare corrente del pensiero
cimrico del sedicesimo secolo, meriterebbero la considerazione degli
studiosi di questioni celtiche. Non hanno la pretesa di essere un'opera
puramente druidica, dato che in essa figurano numerosi personaggi
ed episodi di tradizione cristiana. Ma a tratti si incontra una
vena di pensiero che certamente, qualsiasi altra cosa possa essere,
non e' cristiano e rivela un sistema di pensiero indipendente"
(pag. 299).
Da segnalare che in Galles esiste anche una interessante tradizione
secondo la quale là dove nelle Barddas si nomina Dio, occorre
invece leggere Dei (o anche la Dea Madre e il Dio Bambino), che
ritengo metta in luce l'aspetto più vero del testo, che fa
riferimento alla Divinità in senso generale...
E l'eccellente studioso Christian Guyonovarc'h ritiene che I Barddas
non vanno esclusi da un discorso sulla religione celtica (La societe
celtique, pagg. 185-188).
Quanto alla conoscenza di incantesimi e forme di concentrazione-meditazione,
gli antichi racconti irlandesi, e la tradizione bardica scozzese,
hanno tramandato l'imbas forosnai, il teinm Iaeda e il dichetal
do chennaib (e il metodo bardico di ottenere l'Ispirazione, l'Awen,
anche poetico-letteraria può essere riprodotto ancora oggi,
vedi ad esempio la fine del libro di Ceitlin Matthews, I Celti,
Xenia editore).
L'abbigliamento dei Galli
Su un libro interessante,ma non recente, ho trovato questa descrizione
di sicuro interesse.
Commentando il celebre fregio di Civitalba (l'immagine è
sul sito ) Maria Teresa Grassi ne I Celti in Italia, Longanesi,
Milano 1991, pag. 44, così descrive l'immagine tipica dei
Galli, anche con riferimento alla descrizione di Diodoro Siculo
sotto riportata :
hanno lunghi capelli e baffi spioventi e alcuni sono completamente
nudi, con una collana rigida (torques) al collo e una cintura ai
fianchi, che probabilmente serviva per sospendere la spada.
Si difendono con uno scudo sulla sinistra e tengono la spada, che
però non è conservata, con la destra.
Altri hanno un corto mantello (chlamys) sulle spalle oppure una
corta tunica che lascia soperta una spalla (exomis).
Uno infine presenta, sotto il mantello, una corta tunica in pelle
d'animale, stretta sulla vita da una cintura.
Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, V, 28-30:
I galli sono alti di statura, con una muscolatura guizzante sotto
la pelle chiara.
Di capelli sono biondi, non soltanto per natura, ma perché
usano ritoccare con mezzi artificiali i colori naturali di cui ognuno
di loro è stato dotato.
E infatti si spalmano sempre i capelli con una soluzione di calce,
e se li tirano indietro dalla fronte fino alla nuca e sul collo,
con il risultato di rassomigliare a tanti Satiri e Pan, perché
questo trattamento rende i capelli così spessi e densi che
possono sembrare, in tutto, la criniera di un cavallo. Alcuni di
loro si radono la barba, ma altri se la lasciano crescere un pò;
i nobili si radono le guance, ma si fanno crescere i baffi fino
a coprire la bocca e fungono da setaccio durante in pasto, per cui
vi restano imprigionati pezzi di cibo.
Le vesti che indossano sono sgargianti, tuniche tinte e ricamate
di diversi colori e calzoni che chiamano bracae nella loro lingua;
e portano un mantello a strisce, legato da una fibbia alla spalla,
pesante per l'inverno e leggero per l'estate, intessuto di fitti
tasselli policromi.
Ecco la descrizione di Feidelm, profetessa e guerriera: "Aveva
i capelli biondi. Indossava un mantello variegato trattenuto da
un fermaglio d'oro e una tunica con un cappuccio dal bordo decorato
di rosso. Portava calzari con legacci dorati. Il volto era sottile
in basso e ampio alla fronte. Le delicate ciglia scure ombreggiavano
metà del viso fino alle guance. Le labbra sembravano tinte
di rosso scarlatto. I denti tra le labbra erano una cascata di perle.
I capelli erano acconciati in tre trecce: due avvolte intorno alla
testa, la terza che ricadeva sulla schiena fino a sfiorare i polpacci.
La donna teneva in mano una bacchetta di findruine [ probabilmente
elettro ] con intarsi d'oro. In ogni iride erano incastonate tre
pietre preziose. Era armata, e due cavalli neri conducevano il suo
carro da guerra."
In questo brano si evidenzia la considerazione che i Celti nutrivano
nei confronti della bellezza femminile, per la quale diversi eroi
sono pronti a compiere imprese suicide, e contemporaneamente si
accenna anche al fatto che Feidelm fosse armata, e viaggiasse su
un carro- privilegio, questo, riservato all'aristocrazia guerriera
e simbolo di potere e di forza.
L'eredità Celtica, onnipresente anche oggi in Europa
e in Italia (Venceslas Kruta)
Oggi "è più manifesta la coscienza del ruolo
svolto dai Celti antichi nella formazione dell'Europa ... L'eredità
celtica non si limita alla tradizione popolare, vigorosa e sempre
inventiva - oggi in primo piano - ma comporta numerosi altri aspetti,
più o meno appariscenti e talvolta poco conosciuti al di
fuori delle attuali regioni celtiche.
E' il caso, per esempio, delle letterature antiche a carattere epico
e mitologico dell'Irlanda e del Galles, ben meno note in Italia
di quelle della Grecia o di Roma, delle saghe medioevali dei popoli
germanici, o addirittura dei racconti dell'Oriente antico. Eppure,
le letterature celtiche antiche rappresentano, per la loro originalità
e per la tradizione orale plurisecolare che incorporano, uno degli
elementi più preziosi a nostra disposizione per la comprensione
e lo studio del mondo spirituale dei popoli che svolsero un ruolo
decisivo nella gestazione protostorica e storica dell'Europa.
L'immaginario celtico, ritornato sul continente con l'epoea della
materia di Bretagna e i cicli cavallereschi, marcherà profondamente
anche la mentalità dell'uomo medievale. Molto più
tardi, quando la rivoluzione industriale darà l'inizio ad
una nuova metamorfosi dell'Europa, i "pastiches" ossianici
di James Macpherson alimenteranno lo spirito del movimento romantico,
suscitando un rinnovato interesse per la tradizione letteraria dei
paesi celtici.
I Celti e la loro arte rappresenterebbero un'alternativa di libertà
contrapposta al determinismo e al conformismo ordinato dell'arte
classica...
L'arte celtica" non è più "da considerare
come una derivazione marginale e barbarica dell'arte antica, ma
come una realtà indipendente, con un linguaggio e una concezione
dell'immagine propria...
La cultura dei Celti antichi non costituiva soltanto un preludio
barbaro ad una vera e propria cultura, arrivata, secondo le regioni,
o con il dominio di Roma o con l'arrivo del cristianesimo, ma aveva
invece dato un suo contributo originale alla civiltà europea...
I cambiamenti che avvennero nell'artigianato sotto l'influenza di
Roma toccarono... sopratutto il volume della produzione e l'organizzazione
della distribuzione, e soltanto in pochi casi il miglioramento dei
prodotti.
Lo stesso avvenne nell'agricoltura: gli utensili preromani, rimasti
in uso nelle nostre campagne fino all'introduzione della meccanizzazione,
permettevano delle colture ben adattate alle condizioni climatiche
non mediterranee, che i Romani stessi non avevano sperimentato prima
dell'occupazione della pianura del Po all'inizio del II secolo a.C..
Anche la coltivazione della vite, che è in genere considerata
come un indiscutibile apporto della colonizzazione, sembra invece
fosse praticata, in una varietà vicina alla vite selvatica
- li lambrusco -, in alcune regioni dell'Europa transalpina da tempi
ben anteriori. (in Venceslas Kruta e Valerio M. Manfredi I Celti
in Italia , Mondadori, Milano 1999, 2000, pagg. 7-8)
Un'eredità celtica onnipresente e multiforme è comune
alla maggior parte delle regioni d'Europa.
Ha marcato la vita quotidiana dei suoi abitanti, di generazione
in generazione - dalle isole atlantiche alle steppe dell'Est, dalle
pianure del Nord alle coste settentrionali del Mediterraneo - e
anche se da quasi duemila anni non è più sostenuta
da una lingua comune, continua ad esercitare la sua influenza fino
ai nostri giorni in modo per noi quasi inconsapevole.
Basti ricordare che l'organizzazione dell'anno celtico, con le feste
principali che ne ritmano lo svolgimento, è ripresa nel calendario
religioso della cristianità d'Occidente...
Ancora l'uso augurale del vischio per l'anno nuovo è un altro
elemento di tradizione legato ai Celti.
Gli esempi si possono moltiplicare, I nomi di molte città
ricalcano ancora quelli della loro fondazione celtica ...; Parigi,
Berna, Budapest, Belgrado, Bratislava e in certa misura anche Praga,
erede del vicino oppidum di Zàvist. La situazione è
particolarmente significativa per l'Italia settentrionale, dove
le informazioni di Plinio iil Vecchio, secondo cui si devono ai
Celti città come Milano (Mediolanum), Torino (taurasion),
Bergamo (Bergomum), Como (Comum), Brescia (Brixia), trovano oggi
conferma nei ritrovamenti archeologici. Il ricordo di una quarantina
di popoli gallici è conservato nei nomi di città e
provincie . Il nome del potente popolo dei Boi, che occupò
per due secoli l'Emilia-Romagna attuale si conserva in due regioni:
la Boemia (Boiohaemum) e la Baviera.
Se alle città e alle regioni si aggiungono i nomi di fiumi
e di montagne o di altri elementi del nostro ambiente, si potrà
osservare come il paesaggio quotidiano è ancora profondamente
marcato dal ricordo dei Celti antichi".
(in Venceslas Kruta e Valerio M. Manfredi I Celti in Italia , Mondadori,
Milano 1999, 2000, pagg. 7-12)
Bibliografia ragionata
Opere d'insieme necessarie
Venceslas KRUTA La Grande storia dei celti, Newton & Compton
edizioni Roma 2003
I Celti sono gli antenati di un gran numero di popoli europei e,
sebbene siano scomparsi ormai da molto tempo, le loro lingue sopravvivono
in Bretagna, nella Scozia e in Irlanda, nel cuore di una cultura
viva e feconda. Il loro ruolo fu fondamentale per la formazione
dell'Europa, dato che per secoli esercitarono un dominio culturale,
economico e militare che si estendeva dall'Oceano Atlantico ai Carpazi,
dalle grandi pianure del Nord fino alle rive del Mediterraneo. Gli
scrittori greci e romani ne esaltarono soprattutto le virtù
militari, ma lo studio delle vestigia archeologiche ci permette
oggi di delineare un'immagine più complessa, che sorprenderà
quanti considerano ancora i Celti un popolo "barbaro".
Farne conoscere la storia e la cultura, inquadrandole nel più
ampio contesto europeo, è lo scopo di questo libro che, attraverso
un'attenta analisi delle fonti antiche e una sintesi storica basata
sulle ricerche più recenti, traccia un quadro delle vicende
di questo popolo, dalle lontane origini fino alla perdita dell'indipendenza
e all'affermarsi del cristianesimo.
Venceslas Kruta, nato nel 1939 a Saumur, è dal 1972 direttore
degli studi di protostoria d'Europa all'école Pratique des
Hautes études di Parigi. Laureato in archeologia e in storia
antica, ha diretto numerosi scavi archeologici, in Francia e all'estero.
Autore o coautore di un trentina di libri, di cui alcuni già
tradotti in una decina di lingue, è stato consigliere scientifico
e direttore di mostre internazionali, fra cui quella sui Celti a
Venezia (1991) e quella sui tesori dell'arte celtica, tenutasi a
Tokyo nel 1998.
Sabatino MOSCATI (a cura di), I Celti, Milano, Bompiani (Gruppo
Editoriale Fabbri), sempre in stampa (I ed. Marzo 1991), p. 799,
illustrato; il volume è il catalogo ufficiale della mostra
internazionale sui Celti di Palazzo Grassi, Venezia, 1991, che è
stata definita la "Celtic exhibition of the century" (pag.
254 della recensione della mostra e del volume, M. Ruth MEGAW/ J.
Vincent S. MEGAW, The Celts: the first Europeans?, in pp. 254-260
di Antiquity, Oxford, Oxford University Press, Vol. 66, n. 250,
March 1992).
L'opera riguarda i celti antichi di tutta Europa, l'eredità
celtica ancora attuale e la moderna cultura celtica. Libro massiccio
e insostituibile.
Opera collettiva, nella maggior parte dei casi i saggi che vi sono
contenuti sono la sintesi (la più aggiornata, al momento
della pubblicazione) degli studi archeologici, filologici e storici
sui Celti; alcuni di essi invece, una minoranza, non sono dello
stesso livello. L'apparato iconografico che presenta è inoltre
indispensabile.
Christiane ELUèRE, I Celti "barbari" d'Occidente (titolo originale francese L'Europe des Celtes, Paris, Gallimard, 1992), trad. italiana di Marina Rotondo, ed. ital. a cura di Melita Cataldi, Milano, Electa/Gallimard, "Universale" n. 44, 1994 (ma sempre in stampa), p. 192, illustrato. Un'opera divulgativa, ma che potrebbe fungere da introduzione superficiale all'argomento.
Jan FILIP, I Celti alle origini dell'Europa, traduzione italiana
di A. Gallo Ziffer, Roma, Newton Compton, 1980 (I ed. originale
ceca, Praha, 1960), p. 220, illustrato, che mostra particolare attenzione
per la celticità dell'Europa orientale e danubiana.
Venceslas KRUTA/ Werner FORMAN (ma Forman è il fotografo),
I Celti occidentali (titolo originale francese Les Celtes en occident,
Paris, éditions Atlas, 1985), trad. ital. di Luana Kruta
Poppi, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1986, p. 127, dedicato
ai Celti dell'Armorica e delle Isole britanniche, ma solo fino al
IV secolo dopo Cristo.
I Celti in Italia
Venceslas KRUTA/ Valerio M. MANFREDI, I Celti in Italia, I ed.,
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, "Le Scie", Maggio 1999,
p. V-214, p. 20 di tavole ft., sui Celti quali antenati degli abitanti
dell'Italia del Nord, e in particolare di quelli della Val Padana
e della costiera adriatica fino a Senigallia.
Antonio VIOLANTE, I Celti a sud delle Alpi, Cinisello Balsamo (MI),
Silvana, "Popoli dell'Italia antica", 1993, p. 140, illustrato.
Questi due volumi sono stati i primi a integrare le recenti scoperte
riguardo ai Celti nella pianura padana e nelle Alpi italiane, non
giunti tra VI e IV secolo avanti Cristo con le invasioni di cui
parlava Tito Livio, ma presenti fin dall'inizio del formarsi della
celticità europea nel XIII secolo a.C., con le culture di
Canegrate e Golasecca, 'facies' lombardo-piemontesi della Cultura
dei Campi di Urne. Le scoperte sono il frutto dello sforzo di lavoro
integrato, nello scorso trentennio, di filologi e archeologi, che
ha dimostrato che la lingua dei Golasecchiani, contenuta nelle iscrizioni
lepontiche risalenti fino al VII secolo a.C., era una lingua celtica
Berresford ELLIS (anche scrittore di narrativa fantasy, sotto lo pseudonimo di Peter Tremayne) , The Celtic Empire: The First Millennium of Celtic History c.1000 BC - 51 AD, London, Constable & Co., sempre in stampa (I ed., 1993), p. X-246, p. 16 di tavole, recentemente tradotto in Italiano dall'editore Piemme, col titolo L'Impero dei Celti. Utile ed appassionata sintesi di un celta impegnato per la preservazione dell'eredità celtica.
Jean MARKALE, I Celti. Mito e Storia (tit. orig. francese Les Celtes et la civilisation celtique. Mythe et histoire , II ed., Paris, éditions Payot, 1969), trad. italiana di Renata Carloni Valentini, Milano, Rusconi Libri, "Popoli e Civiltà", I ed. 1982, p. 554 oppure ora Mondadori, ricca di spunti interpretativi...
Opere sulla religione pagana dei Celti
John Matthews , Sciamanesimo Celtico, Edizioni Età dell'Acquario,
Torino 2002, Le tecniche e i metodi di un sistema di lavoro interiore
valido universalmente e basato su antiche credenze celtiche per
esplorare il proprio regno interiore, per diventare uno sciamano
attivo, per salvare la propria anima e per effettuare semplici guarigioni.
Un programma vario e articolato indispensabile per coloro che sono
interessati alla mitologia celtica e all'esoterismo di origine occidentale.
Miranda Jane GREEN, Dizionario di mitologia celtica, Rusconi editore, seria divulgazione accademica, con abbondante iconografia.
Stuart PIGGOTT, The Druids, London, Penguin Books, "Pelican Books", sempre in stampa con successive edizioni aggiornate (I ed., London, Thames & Hudson, 1968), p. IX-193, p. 16 di tavole; di esso vi è stata anche una traduzione italiana, con l'infelice titolo Il mistero dei druidi, sacri maghi dell'antichità, Roma, Newton Compton, 1982.
Giuseppe ZECCHINI, I druidi e l'opposizione dei Celti a Roma, Milano, Editoriale Jaca Book, "Le Edizioni Universitarie Jaca" n. 3, Settembre 1984, p. 155, introvabile e importantissimo. Dello stesso autore il recentissimo Venrcingetorige..
Françoise LE ROUX, il saggio La religione dei Celti, in pp. 93-152 del Vol. 5 di Henri-Charles PUECH (a cura di), Storia delle religioni (titolo orig. francese Histoire des Religions, Paris, Gallimard, 1970), trad. italiana di Maria Novella Pierini, Bari, Editori Laterza, 1977 (con qualche errore di traduzione: i Britanni, ad esempio, risultano sempre Bretoni!).
Françoise LE ROUX/ Christian-Joseph GUYONVARC'H, I Druidi, trad. italiana (dalla IV ed. francese, Les Druides, Rennes, éditions Ouest-France, "De mémoire d'homme: l'histoire", 1986, p. 448) di Carla Ferretto, Genova, ECIG, "Nuova Atlantide", 1990, p. 578; è senza dubbio il più completo studio dell'argomento, molto dettagliato e di alto livello interpretativo. L'opera migliore esistente in materia (anche se l'aprioristico rifiuto delle evidenze archeologiche propugnato da questi dottissimi autori è opinabile)
Peter Berresford ELLIS, Il segreto dei druidi. La vera storia dei potenti sciamani itineranti nell'Europa pre-cristiana (il titolo orig. inglese, più sobrio, è The Druids, London, Constable & Co., 1994), trad. ital. di Simona Angela Comuzzi Scaccabarozzi, Casale Monferrato (Alessandria), Edizioni Piemme, Settembre 1997, p. 391, p. 12 di tavole. Si tratta di un utile libro divulgativo,
Jean MARKALE, Il druidismo. Religione e divinità dei Celti (tit. orig. francese Le druidisme, I ed., Paris, Payot, 1985), sempre in stampa dal 1991 in diverse edizioni (I ed. italiana, Roma, Edizioni Mediterranee, 1991; poi Milano, Arnoldo Mondadori Editore, "Oscar saggi" n. 380), Introduzione all'edizione italiana di Gianfranco De Turris, trad. ital. di Carmine Fiorillo, p. 266. Un testo fondamentale, al quale può essere utile, per allargare l'orizzonte, affiancare altri due testi dello stesso autore: Il Graal, e Merlino e l'eterna ricerca magica, sempre Mondadori editore.
Riccardo Taraglio, Il vischio e la quercia, Edizioni l'età dell'Acquario, 2001, una utilissima sintesi sulla spiritualità celtica.
Alexander Carmichael I Carmina Gadelica: sortilegi e invocazioni dell'Arte druidica , Keltia, Aosta.
Carr-Gomm, Philip, RITI E MISTERI DEI DRUIDI (ma il titolo originale
è la Tradizione druidica).
Partendo dall'etimologia della parola druido, l'autore di questo
libro, capo di uno dei gruppi druidici più importante a livello
internazionale, ricostruisce in modo chiaro e avvincente la religione
degli antichi Spiriti degli alberi della magia e degli incantesimi,
suggerendo l'attualità di una religione che può essere
considerata come un sistema vivo e tuttora in evoluzione. Ho conosciuto
personalmente l'autore, uno psicologo gallese di grandi capacità
comunicative, e l'opera è una introduzione seria e ricca
di spunti sul neodruidismo. pp. 210. € 7,23, Mondadori, Milano
2001.
Emma Relstab Orr, Il Druidismo - Armenia edizioni - Utile introduzione.
Ceitlin Matthews, I Celti . Xenia edizioni, con particolare attenzione all'aspetto spirituale. Opera seria e ottimamente documentata. Utilissima sintesi.
Sylvia e Paul F. Botheroyd, Mitologia Celtica. Lessico sui Miti, Dèi ed Eroi, Keltia, Aosta 2000.
Miranda Jane Green (trad. di C. Lamparelli) Miti Celtici, Mondadori,
Milano.
Margarete Riemschneider (trad. e intr. di R. Lanari) La Religione
dei Celti - una concezione del mondo Rusconi , Milano 1997.
T.W. Rolleston (trad. di E. Campominosi) I Miti Celtici - TEA o Longanesi.
Sopravvivenza del passato celtico nel mondo moderno
Tre libri vanno presi in considerazione sull'eredità culturale
e folklorica lasciataci dai Celti antichi. In primo luogo, riguardo
a Irlanda e Galles, Alwyn REES/ Brinley REES, Celtic Heritage: Ancient
Tradition in Ireland and Wales, London/ New York, Thames and Hudson,
sempre in stampa (I ed. 1961), p. 428, trad. Italiana L'eredità
celtica, edizioni Mediterranee, Roma.
Ward RUTHERFORD, Tradizioni celtiche. La storia dei druidi e della loro conoscenza senza tempo (tit. orig. inglese Celtic Lore: The history of the Druids and their timeless traditions, London, HarperCollins Publishers, "Thorsons", 1993), traduzione, introduzione e note di Francesca Diano, Vicenza, Neri Pozza Editore, Novembre 1996, p. 290, testo divulgativo e diretto al crescente pubblico degli appassionati di celtismoi, ottimo ma dignitoso nel contenuto e interessante per l'attenzione a ciò che è sopravvissuto dell'eredità culturale dei Celti nell'Europa medioevale e moderna.
Sull'Italia del Nord, Marco Fulvio BAROZZI, Tracce Celtiche curiose, misteriose ed inquietanti. Piccolo viaggio all'interno di alcuni segni, misconosciuti o ignorati, del passato celtico antico e medievale nell'Italia alpina e padana, Milano, Edizioni della Terra di Mezzo, "Saggistica", Giugno 2000, p. 236, illustrato.
Vita quotidiana e guerra
Per quanto concerne la vita quotidiana e la cultura materiale delle
tribù dei Celti, si veda Anne ROSS, Everyday Life of the
Pagan Celts, II ed. (I ed. London, B. T. Batsford, 1970), London,
Transworld Publishers, "Carousel Books", 1972, p. 288;
di esso è uscita una nuova -ma più smilza- edizione
riveduta, "updated, expanded and reillustrated", col titolo
The Pagan Celts, London, B. T. Batsford, 1986, p. 160, p. 8 di tavole,
illustrato.
Per gli usi bellici dei Celti, oltre alle parti specifiche delle opere generali citate, vedi il divulgativo Tim NEWARK, I Guerrieri Celti. 400 a.C. - 1600 d.C. (titolo orig. inglese Celtic Warriors 400 BC - 1600 AD, London, Blandford Press, 1986), La Spezia, Fratelli Melita Editori, 1991, p. 143, p. 16 di tavole ft a colori di Angus McBride.
Antichi racconti celtici
G. Agrati e M.L. Magini (a cura di) Saghe e leggende celtiche. I
racconti gallesi del Mabinogion. La saga irlandese di Cu Chulainn
(2 voll) Oscar Mondadori, Milano.
G. Agrati e M.L. Magini (a cura di) Saghe e racconti dell'antica Irlanda. Druidi, bardi e guerrieri (2 voll) Mondadori, Milano.
G. Agrati e M.L. Magini (a cura di) Racconti e leggende dell'antica terra di Cornovaglia (2 voll) Mondadori, Milano, 1995.
G. Agrati e M.L. Magini (a cura di) Fiabe e leggende scozzesi (2 voll) Mondadori, Milano, 1994-2001.
G. Agrati e M.L. Magini (a cura di) Merlino l'incantatore (2 voll) Mondadori, Milano.
G. Agrati e M.L. Magini (a cura di) La leggenda del Santo Graal (2 voll) Mondadori, Milano.
G. Agrati Galvano. Il primo Cavaliere (2 voll) Mondadori, Milano.
Le Scouëzec G., Leggende Della Bretagna Misteriosa, Arcana, Milano 1982.
Boulenger J. (a c.), ed. Italiana a cura di G. Agrati e M.L. Magini, I romanzi della tavola rotonda (2 voll.) Mondadori 2002.
Tavola Ritonda, a cura di Emanuele Trevi, Classici Rizzoli 1999 (opera arthuriana italiana di grande bellezza).
Sciamanesimo celtico
John Matthews , Sciamanesimo Celtico, Edizioni Età dell'Acquario,
Torino 2002
Lo sciamanesimo, probabilmente la più antica disciplina spirituale
di cui si ha conoscenza, è l'eterna arte di vivere in armonia
con la creazione. Lo sciamanesimo celtico deriva dalla tradizione
nativa del Nord-Ovest europeo, ma il contributo che i Celti hanno
portato alla tradizione sciamanica universale è stato per
lo più trascurato.
Matthews illustra in queste pagine le tecniche e i metodi di un
sistema di lavoro interiore valido universalmente, qualunque siano
la nostra religione o il nostro orientamento spirituale, e li confronta
con gli insegnamenti dei nativi americani, australiani e siberiani
con cui esso condivide alcuni elementi.
Peter Berresford ELLIS, Il segreto dei druidi. La vera storia dei potenti sciamani itineranti nell'Europa pre-cristiana (il titolo orig. inglese, più sobrio, è The Druids, London, Constable & Co., 1994), trad. ital. di Simona Angela Comuzzi Scaccabarozzi, Casale Monferrato (Alessandria), Edizioni Piemme, Settembre 1997, p. 391, p. 12 di tavole. Si tratta di un utile libro divulgativo,
J. Matthews, Carte dei Celti. Il sentiero sciamanico della tradizione
celtica. Il Punto d'Incontro, Vicenza
di Rolando Dubini
rolando.dubini@fastwebnet.it
http://guide.supereva.it/musica_celtica_/
http://it.groups.yahoo.com/group/celtegh

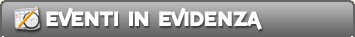

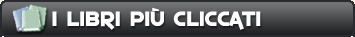
di Michael A. Cremo, Richard L. Thompson2. Archeologia Misterica
di Luc Bürgin3. Archeologia dell'impossibile
di Volterri Roberto4. Archeologia eretica
di Luc Bürgin5. Il libro degli antichi misteri
di Reinhard Habeck6. Rennes-le-Château e il mistero dell'abbazia di Carol
di Roberto Volterri, Alessandro Piana7. Il mistero delle piramidi lombarde
di Vincenzo Di Gregorio8. Le dee viventi
di Marija Gimbutas9. Come ho trovato l'arca di Noè
di Angelo Palego10. Navi e marinai dell'antichità
di Lionel Casson

ARCHEOLOGIA BIBLICA
ECCEZIONALE RITROVAMENTO IN UN TUNNEL SEGRETO IN MESSICOARCHEOLOGIA BIBLICA
CIMITERO DI ANFORE IN DUE NAVI ROMANE NELLE EOLIEARCHEOLOGIA BIBLICA
SCOPERTI VASI DI ARGILLA CRUDI A POMPEIPALEONTOLOGIA
IL GIGANTE DI ATACAMA: UN ALTRO GEOGLIFO CHE SFIDA LA NOSTRA COMPRENSIONE DEL PASSATOARCHEOLOGIA BIBLICA
TROVATA AD ORVIETO LA TESTA DEL DIO DEGLI ETRUSCHIPALEONTOLOGIA
IL MISTERO DELLE TORRI SEGRETE DELL'HIMALAYAARCHEOLOGIA BIBLICA
UNO SCAVO ILLEGALE SCOPRE UN TEMPIO DI THUTMOSE IIIPALEONTOLOGIA
LA BUFALA CHE GESU' FU PADRE E MARITOPALEONTOLOGIA
IL "SEME MAGNETICO" CHE DIEDE VIA ALLA VITA VEGETALE SULLA TERRAPALEONTOLOGIA
TRAPPOLE PER DEMONI SCOPERTE IN INGHILTERRA