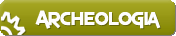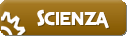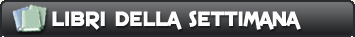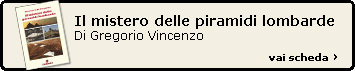Dal "La memoria conta veramente - per gli individui, le
collettività, le civiltà - solo se tiene insieme l'impronta
del passato e il progetto del futuro, se permette di fare senza
dimenticare quel che si voleva fare, di diventare senza smettere
di essere, di essere senza smettere di diventare".
L'origine della parola celti
La parola celti ha origine dal greco keltai che gli abitanti di
Marsiglia, città fondata dai Focesi, attribuirono ai membri
delle limitrogfe e bellicose tribù che popolavano le terre
circostanti.
I Greci dunque li chiamavano Keltoi, ed era il nome che avevano
sentito pronunciare dai Celti stessi, ma in alte occasioni li chiamavano
Galati (gàlatos), mentre i romani, mutuando il nome da quest'ultimo
termine, li chiamavano Galli (o, richiamando la parola greca, celtae).
In tal modo veniva designata una popolazione che parlava una ben
distinta lingua indoeuropea, e che era caratterizzata da una cultura
definita "barbarica" dagli autori classici (grecie romani).
Il termine celti compare per la prima volta negli scritti del geografo
greco Ecateo nel 500 a.C.: egli parla di "Nirax, una città
celtica" e di "Massalia [Marsiglia], città della
Liguria nella terra dei Celti" (Fragmenta Historicorum Graecorum).
Un secolo dopo Erodoto descrive i Celti come coloro che vivono "al
di là delle colonne d'Ercole".
Aristotele sapeva che vivevano "oltre la Spagna", che
avevano conquistato Roma e che tenevano in grande considerazione
la potenza militare.
Ellanico di Mitilene, storico del quinto secoo avanti Cristo, afferma
che i Celti erano un popolo giusto e retto.
Di Eforo (350 a.C.) esiste un frammento poetico secondo il quale
i Celti seguivano le stesse usanze dei "Greci".
Celebre è l'affermazione di Caio Giulio Cesare nel De Bello
Gallico (Liber I - I - La Gallia):
Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae,
aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli
appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.
Gallos
Che, tradotto, suona così:
La Gallia nel suo complesso è divisa in tre parti: una è
abitata dai Belgi, una dagli Aquitani, la terza da quelli che nella
loro lingua si chiamano Celti, nella nostra Galli.
Chi furono i Celti
I Celti sono da sempre identificati come un popolo misterioso e
poco conosciuto, ma in realtà le cose stanno ben diversamente
da quello che oramai è solo un vieto luogo comune, sempre
più svuotato di significato reale.
In tal senso possiamo lasciare la parola a quello che può
essere forse considerato il massimo studioso mondiale della materia,
Vinceslas Kruta, direttore di studi di protostoria d'Europa presso
l'école Pratique des Hautes études, Sciences Historiques
et Philologiques della Sorbona di Parigi
Quando Greci ed Etruschi, nel VI secolo a.C., cominciarono ad interessarsi
all'Europa continentale, vi trovarono insediate, dall'Atlantico
fino ai territori a nord delle Alpi, delle popolazioni di cui documentano
il nome: i Celti, più tardi chiamati anche Galli o Galati.
I Celti erano "numerosi e bellicosi", e "non tardarono
a scontrarsi con i loro vicini meridionali: all'inizio del IV secolo
a.C., un forte esercito attraversò le Alpi conquistando l'Etruria
padana e arrivò fino a Roma, dopo avere sanguinosamente sconfitto
le legioni": "quest'avvenimento drammatico marcherà
profondamente la tradizione storica romana e accorreranno due secoli
di duri combattimenti perché almeno una parte degli invasori
abbandoni l'Italia".In pari tempo una seconda ondata migratoria
si spinge fino alla conca carpatica e ai territori del Danubio,
subito seguita nel 280 a.C. da una spedizione contro la Grecia,
"spazzando via ogni resistenza" e arrivando fino a Delfi
per stabilirsi finalmente in Asia Minore, su un altopiano che da
allora porterà il nome di Galazia. Qui, a diretto contatto
col mondo ellenistico, "si formerà l'immagine dei Galli
selvaggi e ribelli, illustrata nei monumenti dei sovrani di Pergamo".
I Celti diventano così, dopo i Giganti, le Amazzoni e i Persiani,
"l'ultima personificazione della Barbarie che minaccia il mondo
civile".
Occorre attendere Cesare e la sua conquista delle Gallie "perché
gli autori antichi rivolgano di nuovo il loro interesse sui Celti:
scoprono allora un mondo già urbanizzato, capace di assimilare
rapidamente ed efficacemente gli apporti della civiltà romana".
Scavi e rinvenimenti archeologici, da circa un secolo e mezzo a
questa parte, accumulano una massa di informazioni e di materiale
che ci permettono "di ridisegnare l'immagine schematica, incompleta
e deformata, dei Celti, quale ci è stata tramandata dagli
autori e dagli artisti dell'Antichità": "sappiamo
così, che l'invasione dell'Italia non fu tanto un avvenimento
traumatico, repentino e inatteso, ma che fu preceduta da due secoli
di contatti che sembrano pacifici e che contribuirono allo sviluppo
economico dell'Etruria padana. Il tramite furono le popolazioni
di stirpe celtica della cultura di Golasecca della regione lombardo-piemontese".
L'evoluzione dell'arte celtica indica inoltre "che i contatti
diretti dei Celti con l'ambiente greco-etrusco influenzarono profondamente
anche la cultura dei popoli transalpini".
L'espansione danubiana "documenta particolarmente bene la capacità
dei Celti di integrarsi con gli indigeni e di costituire dei nuovi
insiemi etnici compositi di cui le vicende ulteriori dimostrarono
la solidità". Non si può dimenticare che al massimo
della sua estensione, il mondo celtico si allarga dalle isole britanniche
ai Carpazi, dall'Asia Minore alla penisola iberica, comprendendo
anche granparte dell'Italia centro-settentrionale
Questo mondo celtico "conosce uno sviluppo economico notevole
e vede la nascita, nella prima metà del II secolo a.C., di
agglomerati di tipo urbano": "gli abitati, costruiti soprattutto
di legno, non lasceranno all'evidenza delle vestigia spettacolari",
ma "scavi recenti permettono di cogliere l'importanza e la
varietà delle loro attività che coinvolgono tutte
le potenzialità della regione, da quelle agrarie a quelle
minerarie".
Della cultura materiale celtica abbiamo oggetti, utensili, impianti
tecnici, che " illustrano l'abilità degli artigiani
celtici, ricordati dagli autori antichi come modelli in taluni campi:
l'arte del bottaio, del carradore, del fabbro ferraio, mentre le
vestigia vegetali e i resti animali confermano l'abbondanza e la
qualità delle produzioni agricole sottolineate dai testi".
A sfavore della ricerca storica ha però agito "il divieto
religioso di registrare per iscritto tutto ciò che aveva
attinenza con il sacro" e che "ci ha privato di una conoscenza
completa dell'universo spirituale dei Celti". E tuttavia "la
sua ricchezza e la sua originalità si riflettono tuttavia
nelle opere d'arte che rispecchiano una sensibilità molto
diversa da quella del mondo greco-romano": "solo il calendario
gallico, frutto di lunghi secoli di osservazioni astronomiche e
di calcoli sapienti, testimonia in modo eloquente l'alto livello
della scienza celtica".
Conclude Kruta sottolineando come "appare evidente oggi che
i Celti apportarono un contributo fondamentale alla formazione dell'Europa":
"la loro eredità non è percettibile solo nell'ambito
delle tecniche artigianali ed agricole, ma nella toponimia, nelle
mentalità e nei costumi - alcune feste attuali, come quella
del primo novembre, sono ancora quelle del calendario gallico".
E dunque "nel rapporto dialettico tra civiltà romana
e fondo celtico si nutrono le radici dell'Europa medioevale e moderna"
(Venceslas Kruta, 1991 dalla cartella stampa della mostra I Celti,
Palazzo Grassi, Venezia 1991).
La prima celtizzazione (autoctona) del Nord Italia
La prima celtizzazione del nord della penisola italiana viene individuata
nel fondamentale testo Celti in Italia di Venceslas Kruta e Valerio
M. Manfredi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1999, già
nell'età del Bronzo (che Alexandre Bertrand ancora nella
seconda metà dell'800, preferiva chiamare, per Francia e
Italia Settentrionale, come "era celtica") e ha trovato
sviluppo organico (peraltro preceduto dalla civiltà di Canegrate,
che ne anticipa forme e sviluppi) con la Civiltà di Golasecca
(iniziata nel XII secolo a.C.), che a ragione viene considerata
come una delle prime "civiltà celtiche" dell'intero
continente europeo.
Non è perciò strano che proprio nell'area archeologica
golasecchiana sia stata rinvenuta la più antica testimonianza
di una lingua celtica in Europa: da un corredo funebre del secondo
quarto del VI secolo a.C., individuato nei pressi di Castelletto
Ticino, rileviamo infatti il famoso genitivo gallico in alfabeto
etrusco-capenate - Xosoio - graffito su vaso.
Dal testo emergono poi i continui riferimenti allo scambio culturale,
etnico e commerciale con le popolazioni alpine (tra cui i camuni!)
e transalpine che vede un intreccio di relazioni fortissimo tra
gli antenati di quelli che saranno i futuri popoli del Centro Europa.
L'invasione celtica "storica" o "lateniana"
dell'Italia è ricca di vicende storiche e militari che videro
il confronto e lo scontro tra i Celti, e le popolazioni mediterranee
e latine.
Di questo scontro, durato per secoli, vi sono dettagli di grande
interesse, approfonditi nel libro citato, e altri che meritano una
evidenza particolare. Vi è ad esempio chi ha sostenuto la
tesi che i galli senoni (forse con la collaborazione di altri popoli
gallici come boi e insubri, come sembra adombrare Tito Livio, V,
35) che misero a sacco Roma, occupandola e costringendo alla fuga
legioni ed esercito di quella che era già una grande potenza
regionale, agirono istigati dai tiranni di Sicilia: ma la tesi è
piuttosto bizzarra e sicuramente insostenibile se si considerano
gli ottimi rapporti che Roma aveva in quel tempo con quei governanti,
attestati da Tito Livio, IV, 52, dove dopo uina grave carestia,
a fronte dela quale tutti i popoli vicini rifutarono di vendere
grano a Roma (avendo subito da essa innumerevoli guerre e sconfite)
"furono aiutati con generosità dai Tiranni della Sicilia".
Va sottolineata la notevole capacità di sopravvivenza delle
popolazioni celtiche anche in aree molto lontane dalle Alpi, come
nel caso della popolazione celtica dei Senoni (stanziati tra i fiumo
che Tito Livio indica come Utente e Aesim, tra Ravenna e Ancona),
stanziatasi nelle attuali Marche superiori e duramente colpiti dalla
politica di sterminio attuata dai Romani.
Un passo "delle Historie Phillippicae di Pompeo Trogo ricorda l'alleanza militare offerta dai Galli, DOPO la conquista di Roma, a Dionisio I il Vecchio, Tiranno di Siracusa. Tutto lascia credere che sia stata conclusa e l'emporio siracusano di Ancona, a diretto contatto con i Senoni, sia stato senza dubbio uno deiprincipali punti di reclutamento di truppe celtiche. Questi mercenari comatterono per Dionisio non solo nel sud della penisola, ma addirittura in Grecia. Senofonte ne menziona nel 367 a.C. a fianco di mercenari iberici, nel corpo di spedizione siracusano impiegato contro i Tebani" (I Celti prima dell'espansione storica, pag. 206, in aa.vv. I Celti, Bompiani, Milano 1991).
Ecco la eloquente testimonianza di uno storico latino abitualmente
considerato degno di fede, Pompeo Trogo che parla di una ambasceria
dei galli presso Dionigi I intento all'assedio di Reggio (GIUSTINO,
Storie filippiche, introd., traduz. e note di L. Santi Amantini,
Milano, Rusconi, 1981, Historiarum Philippicarum et totius mundi
originum et terrae situs, ex Trogo Pompeio excerptarum libri XLIV
a Nino ad Caesarem Augustum, GIUSTINO, Storie filippiche, introd.,
traduz. e note di L. Santi Amantini, Milano, Rusconi, 1981. Historiarum
Philippicarum et totius mundi originum et terrae situs, ex Trogo
Pompeio excerptarum libri XLIV a Nino ad Caesarem Augustum, Libro
XX, 5):
V. Abbiamo detto che Dionigi il Tiranno, aveva fatto passare la
sua armata dalla Sicilia in Italia, dove era venuto per combattere
i greci, ...
Durante il corso di quella guerra, i legati dei Galli che mesi prima
avevano lasciato Roma in fiamme, vennero a domandare l'amicizia
e l'alleanza di Dionigi, facendo appello al fatto che erano "in
mezzo ai loro nemici e che sarebbero stati di grande giovamento,
sia quando si fosse combattuto in campo aperto, sia assalendo alle
spalle i nemici impegnati in battaglia". Questa ambasceria
riuscì gradita a Dionigi: così, stabilita l'alleanza
e rafforzato, riprese come da capo la guerra.
Per quanto riguarda l'eredità celtica, "il ruolo svolto
dall'italia è stato a lungo mal compreso e mal apprezzato.
Da un lato dai difensori dell'eredità classica, che volevano
vedere nella presenza celtica in Italia un'invasione di barbari
incolti e, alla fine, fortunatamente respinta da Roma. Da un altro
lato dai celtofili che consideravano questa presenza episodica e
marginale, tanto meno significativa per il fatto che i Celti vi
apparivano soltanto come una delle componenti di un insieme culturalmente
ed etnicamente molto diversificato e mescolato".
Recenti ricerche archeologiche e linguistiche "hanno permesso
di riconsiderare la questione e di disegnare un quadro che rivela
il posto importantissimo occupato dal popolamento di origine celtica
nell'Italia settentrionale, e il ruolo fondamentale che ebbero le
intense relazioni tra i Celti d'Italia - a contatto cn Etruschi
e Greci - e i loro congeneri transalpini..."..
Alle vestigia archeologiche "si aggiungono le scoperte di diversi
testi - purtroppo brevi e poco vari - scritti dai Celti antichi
nella loro lingua utilizzando diversi tipi di alfabeti di origine
meditterranea. Questi testi, oltre a fornire materia per lo studio
delle lingue celtiche antiche, costituiscono una prova irrefutabile
dell'estensione delle popolazioni celtofone".
Il mondo dei Celti antichi, "che gli autori greci e latini
ci hanno descritto sotto una luce così sfavorevole, si rivela
invece più ricco e meno semplice di quanto voleva la tradizione,
che attribuiva loro, come merito principale, se non l'unico, quello
di aver assimilato i benefici imposti da Roma".
Appare sempre più evidente "che la perdita dell'indipendenza
non ha significato uno sconvolgimento immediato e radicale della
situazione preesistente: il sistema socio-economico preromano continua
infatti a funzionare senza subire modificazioni importanti, e i
Romani stessi integrano e sviluppano numerosi elementi già
esistenti - santuari, insediamenti, reti viarie, mercati, ecc.".
Gli aggettivi "gallo-romano" (riferito alla Gallia cisalpina
e transalpina), "celto-romano" (per le regioni danubiane),
o "romano-britannico" esprimono la doppia filiazione di
queste facies provinciali e il ruolo che svolse il sostrato celtico
nella loro formazione". (in Venceslas Kruta e Valerio M. Manfredi
I Celti in Italia , Mondadori, Milano 1999, 2000, pagg. 12-14)
Chiusi, Brenno e il saccheggio celtico di Roma
Da tempo nella pianura padana si erano venute ad insediare popolazioni
celtiche provenienti da oltralpe: Salassi, Insubri, Cenomani, Lepontini,
Boi e Senoni...per i romani erano tutti "Galli". Si erano,
tra l'altro, fuse con le popolazioni celtiche autoctone, dell'area
di Golasecca (che avevano radici lontane, nelle genti della cultura
protogolasecchiana di Canegrate, e dunque molto prima del 1000 a.C.).
Così, quando intorno al 390 a.C. a Roma giunse la notizia
che lassù, nella Pianura Padana, queste popolazioni galliche
si stavano muovendo verso sud alla ricerca di nuovi spazi, un brivido
di terrore agitò la popolazione dell'Urbe.
Tito Livio, lo storico romano originario di Padova che offre un
ampio resonto di questo periodo storico nella sua monumentale opera,
pone alla base del rovescio romano una banale storiella d'alcova:
a detta dello storico patavino sembra che un certo Arunte, vinaio
originario della cittadella etrusca di Chiusi, avendo scoperto una
tresca tra sua moglie e il patrizio etrusco Lucumone, e volendo
indi vendicarsi dell'affronto subito rivalendosi contro la sua città,
chiamasse i Celti offrendo loro del buon vino in cambio del loro
aiuto, e allettandoli quindi con la grande disponibilità
di beni esistente a Chiusi. Gli abitanti di Chiusi, terrorizzati,
chiesero aiuto ai Romani. Questi inviarono un paio di ambasciatori
per chiedere ai Celti quale fosse lo scopo reale della loro minacciosa
avanzata nel territorio etrusco.
Scrive Tito Livio V, 33:
"Vuole la tradizione che questo popolo, attratto dalla dolcezza
dei prodotti e soprattutto del vino, che a quel tempo costituiva
per loro un nuovo piacere, abbia attraversato le Alpi e si sia impadronito
delle terre precedentemente abitate dagli Etruschi; chi poi avrebbe
mandato il vino in Gallia sarebbe stato un tale Arrunte di Chiusi
spinto dall'odio per Lucumone che gli aveva sedotto la moglie...
Prosegue Tito Livio, V, 35
Gli abitanti di Chiusi mandarono ambasciatori a Roma per chiedere
aiuto al Senato. Quanto ad aiuto non ottennero nulla; furono invece
mandati in qualità di legati tre figli di Marco Fabio Ambusto,
i quali, in nome del popolo romano, ammonissero i Galli di astenersi
da atti di ostilità contro alleati e amici del popolo romano
che non li avevano in nessun modo provocati.
Dunque nel 390 a.c. (per alcuni testi nel 387 a.c.), approfittando
dell'indebolimento degli etruschi, la tribù dei senoni, al
seguito del suo comandante Brenno (ma è dubbio se fosse un
nome proprio o un titolo onorifico) , decise di spingersi al sud,
alla ricerca di nuovi territori, ma soprattutto di nuovi bottini.
Giunsero a Chiusi e la posero sotto assedio. Gli abitanti della
città, chiesero aiuto a Roma, circostanza peraltro piuttosto
singolare considerando quanto fossero stati difficili, nel passato,
i rapporti tra le due città.
Una delegazione di romani, andò dunque a parlamentare con
i "celti", ma la trattativa non ebbe un buon esito e gli
ambasciatori romani si schierarono apertamente con gli abitanti
clusini.
In tale occasione, l'ambasciatore Quinto Fabio, venuto evidentemente
a Chiusi con intenti già di per sé bellicosi, trucidò
senza motivo un capo dei Celti. L'affronto generò la collera
e la reazione dei "barbari", che, comandati da Brenno,
decisero di marciare direttamente su Roma per ottenere giustizia.
Racconta lo stesso Livio che l'Urbe fu inondata dal panico.
Scrive Tito Livio:
Dal canto loro, i Galli, quando seppero del provocatorio onore
fatto ai violatori del diritto delle genti e del nessun conto che
si era avuto della loro ambasceria, furenti di ira, che quella gente
non sa dominare, tosto levarono il campo e con rapida marcia si
incamminarono........ Tutto, davanti e all'intorno, era ormai occupato
dai nemici, e quella gente per istinto portata a inutili schiamazzi
faceva rintronare orrendamente la regione di canti selvaggi e di
urli strani (V, 37).
Tanto non solo la fortuna, ma anche l'abilità tattica stava
dalla parte dei barbari (V, 38)
La notizia mise in agitazione il Senato, che fece un ricorso alla
leva generale "tumultus", per cercare di fermare l'invasione
gallica, ponendo uno sbarramento sul corso dell'Alia, un piccolo
affluente del Tevere. Venne nominato in fretta dittatore M. FURIO
CAMILLO (forse, sulla sua figura essitono molti dubbi).
Ma l'esercito romano, venne rapidamente sbaragliato ed i soldati
scapparono, forse impauriti dall'aspetto insolito e particolarmente
feroce dei loro avversari.
Stando agli storici antichi, questi guerrieri alti, biondi e incredibilmente
forti avevano il costume di lottare in modo furioso, nudi, quasi
fossero posseduti da una furia soprannaturale, una forza magica,
o meglio divina, che li possedeva, e terrorizzavano i nemici urlando,
picchiando le spade con gli scudi, suonando trombe da guerra che
emettevano suoni terrificanti, e cantando canti selvaggi.
Fu sull'Allia dunque, un fiumiciattolo a undici miglia dalla città,
che i tribuni militari romani approntarono alla meglio e in fretta
le difese. Fu costruito un terrapieno che doveva servire come luogo
di avvistamento e come base per le riserve, alla sinistra del quale
erano schierate le truppe. Se si fosse riusciti ad attirare i Celti,
li si sarebbe potuti accerchiare facilmente e averne ragione in
breve tempo. Ma Brenno, anziché attaccare il grosso dell'esercito,
si gettò coi suoi sull'altura, investendo le riserve lì
appostate e costringendole ad unirsi al resto delle truppe schierate
sulla riva dell'Allia. I legionari iniziarono a fuggire senza nemmeno
combattere; molti annegarono nel tentativo di attraversare il Tevere,
ma i più furono raggiunti dal furore dei "barbari".
Solo i soldati dell'ala più esterna riuscirono a salvarsi,
ritirandosi in parte a Veio, e in parte battendo a rotta di collo
verso Roma.
Era il 18 luglio del 387 a.C. (o 390 a.C. secondo altre fonti),
data che da quel momento in poi verrà tradizionalmente ritenuta
nefasta nel calendario romano. Il Dies Alliensis, , il giorno della
battaglia sul fiume Allia, fu segnato sul calendario come giorno
nefasto per antonomasia e avrebbe accompagnato i Romani antichi
per tutto il corso della loro storia
Molti di loro si rifugiarono a Veio oppure a Cere dove si unirono
ad una parte della popolazione romana, che presa dal panico, aveva
già abbandonato la città.
Brenno e i suoi tuttavia non seppero sfruttare la vittoria: invece
di incalzare i Romani in città e annientarli, si dedicarono
secondo il loro costume a celebrare la vittoria tra canti e banchetti.
A Roma arrivarono solo tre giorni dopo, e la trovarono immersa in
un silenzio spettrale. Tutti gli abitanti della città si
erano trincerati sul Campidoglio; erano rimasti solo alcuni dei
vecchi patrizi che, non essendo in grado di affrontare la battaglia,
avevano deciso di morire dignitosamente seduti sui loro scranni,
avvolti nelle loro toghe più preziose
I galli non trovarono dunque la benchè minima resistenza
ed in poco tempo raggiunsero le mura di Roma, che trovarono completamente
sguarnite.
Nel corso dell'assedio, nella città si sviluppò un
grande incendio che bruciò gran parte delle abitazioni, che
allora erano in legno con tetti di paglia.
I galli penetrarono facilmente nella città, poichè
i difensori avevano persino dimenticato di chiuderne le porte, e,
non trovando alcuna opposizione, si dedicarono al saccheggio.
I romani avevano in buona parte abbandonato la città, altri
si erano chiusi in casa e altri ancorai si erano rifugiati nella
rocca del Campidoglio, che per le sue caratteristiche era difficilmente
espugnabile. Lì vi avevano portato il "fuoco sacro",
sotto la custodia delle "vestali", e le immagini dei loro
dei.
Solo i senatori erano rimasti al loro posto, nella Curia, dove vennero
tutti uccisi, secondo Tito Livio.
Narra Livio che i Celti, aggirandosi nella città e trovandola
vuota, avvistando questi strani figùri, li scambiarono per
delle statue e ne ebbero timore. Uno dei guerrieri per verificare
se fossero vivi, tirò ad uno di essi la barba: questo reagì
colpendolo alla testa con un bastone, scatenando la reazione dei
Celti. I patrizi furono massacrati tutti. Brenno decise poi di attaccare
la rocca del Campidoglio.
Tito Livio (V, 47) narra:
In Roma, provveduto, poi, nel modo migliore che la situazione
permetteva, a tutto quello che poteva servire alla difesa della
rocca, gli anziani ritornarono alle loro case ad attendere l'arrivo
dei nemici, fermamente decisi a morire. Quelli di essi che avevano
coperto cariche curuli, volendo morire con i segni distintivi della
loro pristina dignità, delle magistrature esercitate e dei
loro meriti, rivestirono la sontuosissima toga usata da chi reggeva
il carro degli dei e da chi riportava il trionfo e si assisero sulle
sedie eburnee nel centro della casa. E narrano anche alcuni che,
ripetendo una formula recitata dal pontefice massimo Marco Folio,
si siano offerti vittime per la patria e per i Romani Quiriti. I
Galli o che la pausa della notte avesse affievolito il desiderio
di combattere, o perché non avevano ancora conosciuto le
incertezze di una battaglia, e nemmeno ora dovevano ricorrere a
violenti assalti per conquistare la città, senza furore,
senza entusiasmo, fecero il loro ingresso in Roma il giorno seguente
da porta Collina, tutta aperta, e giunsero al Foro, volgendo gli
sguardi dai templi degli dei alla rocca che, sola, pareva minacciasse
guerra. Poi, lasciato un piccolo presidio per non correre il pericolo
di un attacco dalla rocca e dal Campidoglio mentre erano dispersi
qua e là, si divisero per predare nelle vie completamente
deserte: gli uni raggruppati fanno irruzione nelle case vicine,
gli altri corrono a quelle più lontane, credendole più
ricche di preda, perché intatte; poi, di nuovo, presi da
paura per la stessa solitudine, nel timore di essere sorpresi così
isolati dai nemici, tornano a riunirsi nel Foro e nelle sue adiacenze:
e lì, trovando chiuse le case del popolo, aperti invece gli
atri di quelle signorili, rimangono più titubanti ad entrare
in queste che in quelle, perché nei vestiboli aperti intravedevano,
con un senso di rispetto religioso, uomini seduti che parevano altrettante
divinità non solo per l'abbigliamento e per l'aspetto più
che umani, ma anche per la maestà che spirava dai loro volti
severi. E si dice che, mentre rimanevano estatici a riguardarli
come fossero statue, un Gallo si fece coraggio ad accarezzare la
barba di uno di essi, che allora tutti portavano lunga, Marco Papirio,
che lo colpì sul capo con lo scettro d'avorio: di qui l'ira
del gallo e l'inizio della strage, estesa poi a tutti gli altri
seduti sui loro seggi. Massacrati i capi, non venne risparmiato
più nessuno; le case furono saccheggiate e, quando furono
spogliate di tutto, incendiate.
I galli, dopo aver saccheggiato e distrutto parte della città
(ma non tutta, come nota con meraviglia Tito Livio, forse abituato
a leggere il ben diverso trattamento che i romani riservavano alle
città sconfitte), decisero allora di attaccare il Campidoglio,
e qui si realizzò, secondo la tradizione, il primo degli
episodi leggendari (probabilmente inventati di sana pianta in epoca
posteriore) con i quali i romani cercavano probabilmente di compensare
la forte umiliazione subita.
Secondo questa leggenda (che gli storici giudicano inventata di
sana pianta da annalisti romani compiacenti con le sorti magnifiche
e progressive dell'urbe eterna), i galli di Brenno avevano scoperto
un cunicolo sotterraneo che arrivava all'interno della rocca capitolina
e durante una notte lo utilizzarono per espugnare l'ultimo baluardo
difensivo di Roma. Ma il tentativo di intrusione, fu sventato dalle
oche sacre a Giunone, che spaventate cominciarono a starnazzare,
svegliando il comandante della guarnigione, l'ex console Marco Manlio,
il quale si oppose con decisione ai primi invasori, respingendoli.
In virtù di questo episodio, Marco Manlio, venne chiamato
Capitolino.
Intanto i galli cominciavano a subire le prime sconfitte: un loro
campo, venne distrutto da un esercito composto da cittadini di Ardea
e guidato da Furio Camillo, il comandante romano che, dopo aver
conquistato Veio, era stato esiliato a causa delle sue posizioni
eccessivamente antiplebee.
Brenno cominciava ad essere stanco di Roma, quello che c'era da
razziare, l'aveva già razziato, il Campidoglio si dimostrava
inespugnabile, e gli episodi di resistenza aumentavano.
Così propose ai magistrati romani di riscattare la città:
gli invasori galli avrebbero abbandonato Roma in cambio di mille
libbre d'oro.
I Celti avevano bruciato tutto e non avevano più rifornimenti.
Brenno pretese una somma d'oro esorbitante, che solo a fatica poteva
essere reperita. Mentre l'oro veniva pesato, i Romani iniziarono
a mettere in giro la voce che i Celti stessero usando pesi falsi
per imbrogliarli.
Alle proteste dei magistrati, Brenno, con arroganza e determinazione
sovrana, rispose gettando la sua spada sulla bilancia, pretendendo
in questo modo un'ulteriore quantità di oro, e contemporaneamente
urlando in un latino stentato: "Vae Victis" (guai ai vinti).
Tito Livio (V, 48) narra:
...mancando il nutrimento - i servizi di guardia si susseguivano,
e il corpo indebolito quasi cedeva sotto il peso delle armi -, fu
presa la decisione di arrendersi o di riscattarsi, quali che si
fossero le condizioni, tanto più che i Galli davano aperta
assicurazione che avrebbero tolto l'assedio dietro un compenso non
eccessivo. Il senato tenne seduta e affidò ai tribuni militari
l'incarico di trattare. Quinto Sulpicio e Brenno, capo dei Galli,
vennero ad un abboccamento e si accordarono per un riscatto di mille
libbre d'oro: a tanto si comprava il popolo che tra breve avrebbe
avuto il dominio del mondo. Il patto, di per se stesso umiliantissimo,
fu per di più aggravato da un'indegna prepotenza: i Galli
apportarono pesi alterati, e poiché il tribuno non li voleva
accettare, il Gallo insolente vi aggiunse la propria spada, e fu
udita allora quella parola intollerabile per un Romano: " Guai
ai vinti".
E qui accade, secondo una tradizione assai tarda e fin troppo fantasiosa,
il secondo episodio leggendario: mentre i romani chiedevano tempo
per procurarsi l'oro che mancava, Camillo (che secondo alcuni studiosi
era già deceduto da tempo) raggiunse Roma con un nuovo esercito
e trovandosi di fronte Brenno gli mostrò la sua spada e gli
urlò in faccia:
"Non auro, sed ferro, recuperanda est patria" (non
con l'oro, ma con il ferro, si riscatta la patria).
Le circostanze della presunta riscossa romana (che pare essere una
invenzione posteriore per gratificare la coscienza di color che
domineranno poi il mondo occidentale) vengono così delineate
da Tito Livio (V, 44):
(parla Camillo) "...Codeste che ci corrono addosso alla
rinfusa sono genti a cui natura diede un gran corpo e facili entusiasmi
più che non fermezza d'animo; perciò nella lotta si
avvantaggiano più del terrore che non della forza....Sazi
di cibo e di vino ingordamente trangugiati, al sopraggiungere della
notte si sdraiano a dormire dove e come capita, lungo i corsi d'acqua,
senza provvedere a difese, senza sentinelle, senza corpi di guardia,
ora poi resi anche più incauti del solito dai successi...."
Fu così che (racconta la versione poco attendibile di Tito
Livio) l'esercito romano si scagliò contro l'invasore, costringendolo
alla fuga. Furio Camillo (che forse era già deceduto da tempo)
seguì i galli per un tratto, sconfiggendoli a più
riprese, per poi tornare a Roma, dove ricevette un grande trionfo.
Fu proprio lui ad avviare la rifondazione della città: Roma
era stata ferita gravemente, ma non era ancora morta e dopo pochi
anni avrebbe ripreso il suo processo di grande espansione.
In realtà Camillo (se si vuol seguire Tito Livio) fu nominato
dittatore e cercò di rimettere insieme i cocci di quello
che era rimasto, pregando i suoi concittadini di non abbandonare
la devastata Roma per l'ancora intatta e da poco conquistata Veio
Tuttavia L'intervento di Camillo e la sua vittoria sui Galli non
sono mai esistiti nei termini riportati fantasiosamente da Tito
Livio.
Camillo non è neanche nominato da Polibio (che è un
autore ben più antico, di Livio, e quindi più vicino
agli eventi) ed Aristotele, che scrisse appena cinquant'anni dopo
la vicenda, attribuisce al salvatore di Roma il nome di "Lucio".
Il prenome di Camillo era "Marco" e Lucio probabilmente
è Lucio Albinio, che portò in salvo i tesori sacri
dell'Urbe a Cere.
Inoltre, della presunta vittoria romana non ne sapevano nulla gli
storici prima del II secolo; dunque la vicenda fu sicuramente inventata
per salvare la reputazione di Roma, in quel periodo in piena espansione.
Scrive infatti Polibio, I; 6: "i Galli conquistata Roma con
la forza, la occupavano tutta, eccetto il Campidoglio. Allora i
Romani, dopo aver patteggiato la cessazione delle ostilità
a condizioni favorevoli ai galli ..."
Anche se da quel momento e per quasi mezzo secolo, Roma, dovette
fare fronte a molti conflitti nei quali i suoi tradizionali avversari,
volsci, equi, etruschi e latini, tentarono di approfittare del suo
particolare momento di debolezza. Anche i galli provarono ancora
a saccheggiarla, durante le loro tipiche scorribande, ma stavolta
senza successo.
Marco Manlio Capitolino, paradossalmente, passato dalla parte della
plebe, venne "proditoriamente" accusato di tradimento
daipatrizi e gettato dalla rupe Tarpea (che pure aveva coraggiosamente
difeso).
Gli venne imputatata sopratutto l'attività di difesa intransigente
dei diritti della plebe, oppressa dallo strapotere dei patrizi,e
pagò con la vita il suo atteggiamento politicamente rivoluzionario..
La fondazione (mitica) di Medhelan(ion) e la storia della Milano
celtica
La fondazione mitologica di Medhelan-Mediolanion (o Mediolanion
secondo V.Kruta) può collocarsi attorno al 600-590 a.C.
Mediolanium, (Milano), è la forma latinizzata del celtico
continentale antico Medhelanion o Medhelan, ossia "santuario".
La notizia è riportata sotto forma di mito da Tito Livio,
Storia di Roma dalla fondazione, V, 33-35, che fornisce come termine
di raffronto cronologico il regno di Tarquinio Prisco (616-579 a.C.)
e la fondazione di Marsiglia da parte dei coloni focesi (600 a.C.
ca.). Il leggendario fondatore è Belloveso, della tribù
dei Biturigi, nipote del grande re transalpino Ambigato.
Secondo una antica tradizione milanese, Belloveso vide un animale
sacro, una scrofa semilanuta, animale sacro alla Dea celtica Belisama
(ancora oggi presente in via Mercanti, con un antichissimo bassorilievo
successivamente incorporato nel Palazzo della Ragione del 1200),
e da questa apparizione, da questo segno degli Dei, venne indotto
a fondare il centro sacro di Medhelan.
Vi è un'altra leggenda che è interessante riportare.
Il tutto inizia con la marcia di Belloveso, proveniente dalla Francia,
che giunge in quella che viene definita "Gallia Cisalpina"
nei dintorni del Seveso. Il Seveso viene indicato come piccolo fiume
che attraversa una zona degli Insubres, stirpe affine alla gente
di Belloveso. Secondo il calendario celtico era il giorno del capodanno
celtico (il "giorno di Samhain") e, riporto come c'è
scritto " in quell'istante Antares, la stella più brillante
della costellazione dello Scorpione, sorgeva insieme al sole.".
Non si sa a cosa fosse dovuta la sosta, forse ad un fatto straordinario, ma in ogni caso Belloveso ed i suoi si fermarono presso il fiume quando all'improvviso scoppiò un furioso temporale con grandi fulimini e tuoni che così raccontato mi ricorda certi temporali davvero terrificanti che ho visto solo qui in pianura padana. Ma, tornando al racconto, tra fulmini e tuoni cade anche una violenta folgore che scaricò tutta la sua potenza nel bosco provocando un'incendio così devastante che la pioggia non riuscì a salvare le piante dal rogo dal quale, il giorno seguente, risultarono salve solo due grosse querce che benchè quasi distrutte si ergevano ritte in mezzo ai tizzoni ancora ardenti e la cenere.
Il sole illuminando le due piante ne tracciò sul terreno
l'ombra tanto che sembrava tracciasse in realtà un percorso.
Così doveva apparire ai Celti che probabilmente ritennero
tale fatto un dono degli dei e considerando quella somma di segni
come di buon auspicio spianarono il terreno arso e lo ripulirono
dai resti dei tronchi carbonizzati recintandolo. Tale area venne
considerata sacra, un santuario all'aperto, e fu chiamata Medhelanon
(luogo centro di perfezione) . Lo stesso nome fu dato al villaggio
che nacque appena poco distante dopodichè nell'area bruciata
rinacquero arbusti, piante, erbe e fiori (La Leggenda è tratta
da "Il Mondo dei Celti nelle leggende Milanesi" di Giorgio
Fumagalli. Saggio inedito.).
I Galli stavano cercando un posto dove stanziarsi (all'epoca la
pianura padana era un'enorme luogo di foreste e paludi) e avrebbero
considerato sacrilega l'idea di distruggere gli alberi della foresta
che per i Celti è sacra. Il fatto che gli Dei avessero provveduto
a procurare loro un spiazzo attraverso l'incendio evitò loro
di compiere un sacrilegio e quindi venne considerato un dono degli
Dei stessi che posero fine al loro errabondare, secondo unmodo di
pensare peraltro comune ai diversi popoli di origine indoeuropea
dell'epoca..
Le origini di Milano tra storia e archeologia
Scrive Ermanno Arslan:
Gli "scavi hanno ... rivelato .. il più ampio contesto
della cultura 'golasecchiana padana', in cui si inserisce l'esperienza
protourbana milanese" (nella zona dell'attuale Policlinico
un primo grosso insediamento)..
Il mondo indigeno si organizza in grandi ambiti territoriali, conmarcate
differenze culturali e realtà protourbane centrali, che gravitano
in parte verso le valli alpine a causa delle ricchezze minerarie:
le valli del Ticino, la Valsasssina, la Valcamonica.
I centri noti propongono con poche eccezioni la rete delle città
dei secoli successivi: Brescia, Bergamo, Milano. L'antica Como (Comum
Vetus) si svilupperà sulla sponda del lago in età
romana: dai documenti epigrafici risulta che in essa era usata la
lingua celtica.
Queste città erano vaste quasi quanto quelle romane.
Il centro golasecchiano di Milano ... si estendeva per decine di
ettari. .. circa la struttura urbanistica di questi insediamenti
.. l'esempio di Comum Vetus indica una occupazione a piccoli nuclei
sparsi, con spazi liberi all'interno del perimetro urbano...
..le istituzioni ... dovevano essere evolute ... tanto da permettere
il controllo di ampi territori e di fronteggiare gli Etruschi ai
confini meridionali.
Notevole doveva essere lo sviluppo economico, nel quale forse giocava
un certo ruolo anche la moneta.
Questi insediamenti protourbani della tarda cultura di Golasecca,
e con essi Milano, non scompaiono con l'irruzione dei nuovi gruppi
celtici all'inzio del IV secolo, con la presenza di materiali (fibule,
ceramica anche dipinta) di origine celtica (cultrua di La Tene).
(Ma) ...le cttà ... erano divenute sedi di culti comunitari
dei clan insediati nelle campagne, o erano soltanto il luogo destinato
a riunioni politiche o militariperiodiche, assssemblee o concili.
Ciò potrebbe spiegare la ridotta realtà demografica"
(Archeo, aprile 1988, pag. 19).
Scrive L'archeologo bolognese Daniele Vitali di Bologna, ne I Celti,
Bompiani 1991, pag. 234, a cura di Sabatino Moscati:
"Le diverse popolazioni celtiche, che nel IV e III secolo
a.C. abitarono la vasta regione denominata Insubrium, si configurano
come le eredi dirette delle precedenti comunità di Golasecca.
La ricostruzione di Livio che sinteticamente narra dell'arrivo di
Belloveso con "Biturgi, Arverni, Senoni, Edui, Ambarri, Carnuti,
Aulerci" (Livio, V, 34) nell'Italia occidentale, dove la regione
era chiamata da tempo immemorabile Insubrium (come un pagus degli
Edui, fino ad allora celti transalpini) esprime bene la coscienza
di una stratigrafia del popolamento di lunga data, parallela a quella
delle regioni a sud del Po abitate da Etruschi, Umbri, e Liguri.
Il buon auspicio portò alla fondazione di Mediolanum.
Gli scavi urbani di Milano mostrano sorprendentemente l'antichità
del centro cela il ruolo di perno politico degli Insubri"
Cronologia della Milano celtico-insubre.
Intorno al 390 a.C. i Galli Senoni di Brenno passano dirigendosi
verso sud (ove sconfissero poi i romani sul fiume Allia, e saccheggiarono
Roma, occupandola per sei mesi). La leggenda narra la "rifondazione"
di Mediolanum (Milano) col nome di Alba, con lo sviluppo di un insediamento
non più solo sacro, ma anche civile.
Nel 385 a.C. gli Insubri (i celti che avevano come loro capitale
Milano) si alleano con Velletri, Tivoli e con Dionigi di Siracusa
contro Roma.
Nel 225 a.C. una coalizione di Galli (Insubri, Boi, Taurisci e i
Gesati transalpini) viene sconfitta a Talamone dai Romani guidati
dal console Emilio Papo.
Polibio riporta che in occasione di questa guerra gli Insubri trassero
le loro insegne, dette inamovibili, da un tempio dedicato alla loro
dea (equiparata dai Romani a Minerva-Atena, ovvero la luminosa e
bianca dea celtica Belisama). Secondo la tradizione milanese il
tempio era ubicato sul luogo ove successivamente venne edificata
la basilica di S. Tecla in piazza Duomo: Tuttavia la ricerca archeologica
ha evidenziato la presenza di un fossato difensivo intorno a un
edificio in via Moneta datato IV sec. a.C.: questo fa pensare ad
un importante luogo sacro, rimasto fortificato fino alla seconda
metà del II sec. a.C., che secondo alcuni sarebbe proprio
il Tempio di Belisama.
Nel l 223 a.C. vi fu dapprima una pace separata fra i Romani e i
Galli Anari del Parmense, dopo di che il console Caio Flaminio attraversò
il Parmigiano per portare guerra ai Celti Insubri fondatori di Milano.
I Romani entrarono nel territorio degli Insubri presso la confluenza
dell'Adda col Po, si allearono coi Cenomani e iniziano a devastare
i villaggi della pianura. Gli Insubri scesero in campo con 50.000
uomini, ma, dopo una prima vittoria, vengono sconfitti al fiume
Klousios dal console Flaminio.
Nel 222 a.C., in primavera, i Romani invadono nuovamente il territorio
degli Insubri ed assediano Acherra, alla confluenza fra Adda e Serio.
Gli insubri invadono il territorio degli Anari, sotto controllo
romano, e assediano Casteggio, Clastidium, sulla riva del Po.
Il console Marcello riesce infine a sbaragliare l'armata celtica
per poi riunirsi al collega Cornelio Scipione e riprendere l'assedio
ad Acherra-Acerrae. Gli Insubri, coadiuvati dai Gesati della valle
del Rodano guidati dal re Virdomaro (o Britomarto), si apprestano
a respingere l'attacco romano. I consoli Gneo Cornelio Scipione
e M. Claudio Marcello avanzano verso l'Adda e assediano Acerrae
(Pizzighettone) per entrare nel territorio insubre. Eliminato con
un'improvvisa diversione l'esercito dei Gesati (a seguito dell'uccisione
del loro Re, in duello, da parte di Claudio Marcello, che consacrerà
le terze spoglie opime al Tempio di Giove Feretrio, in Roma, dove
la lapide dei fasti trionfali ne registrano il trionfo come avvenuto
su galli insubri e germani (la più antica menzione di questo
popolo), la guerra o si sposta a Milano, che viene occupata dai
Romani - secondo alcuni storici guidati da Scipione, per la leggenda
locale dal console Marcello. Per l aprima volta i romani entrano
a Milano.
Nel 218 a.C. dal territorio dei Galli vengono dedotte le colonie
latine di Piacenza (Placentia ) e Cremona, con 6.000 coloni l'una.
L'arrivo dell'esercito di Annibale, che dopo aver attraversato le
Alpi giunge nella pianura padana, spinge alla rivolta Boi e Insubri,
che riescono così a liberarsi del dominio romano. Gli Insubri,
insieme ad altri celti cisalpini, si arruolano nell'esercito di
Annibale.
La battaglia del Lago Trasimeno del 21 giugno del 218 a.C.vide
lo schieramento cartaginese, con gli alleati, i celti cisalpini,
travolgere le legioni romane, che subirono una disastrosa sconfitta.
L'evento emblematiche che segno il destino della battaglia fu l'uccisione
del console Gaio Flaminio da parte di un nobile insubre, il cavaliere
Ducarios, la cui vicenda, invero eroica (visto il gran numero di
romani che difendeva il proprio console), è tramandata con
una certa ricchezza di dettaglia da Tito Livio.
Ma appunto cinque anni dopo Flaminio incontrò la morte in
battaglia per mano di un cavaliere insubre, Ducarios.
|
|
| Esempio di moneta celtica (C) Institute of Archaeology, Oxford. |
Tito Livio, Storia di Roma, Libro XXII, 6
"Si combatté per quasi tre ore e dovunque ferocemente;
tuttavia, la battaglia fu più violenta e minacciosa attorno
al console (Gaio Flaminio).
Lo seguiva il fiore dei soldati, mentre egli stesso era attivo nel
soccorrere i suoi in qualunque punto li scorgesse oppressi ed in
grave disagio.
I nemici si scagliavano con grande violenza contro di lui, che si
distingueva per l'armatura, mentre i suoi concittadini lo proteggevano,
finché un cavaliere insubre, che si chiamava Ducario, riconoscendo
il console anche dal volto, rivolto a quelli della sua gente urlò:
"Eccolo, è proprio costui che fece strage delle nostre
legioni e saccheggiò i nostri campi e la nostra città!
Io consacrerò questa vittima come un'offerta ai Mani dei
concittadini indegnamente uccisi".
Cacciati gli sproni nel ventre del cavallo, si gettò impetuosamente
in mezzo alla foltissima schiera dei nemici ed abbattuto prima lo
scudiero che si era lanciato incontro a lui che avanzava minaccioso,
trafisse il console con l'asta; i triari, opponendo gli scudi, tennero
lontano l'assalitore che bramava di spogliarne il corpo.
Cominciò allora la fuga di gran parte dell'esercito ed ormai
né il lago né i monti si opponevano più allo
sgomento; i Romani tentavano di fuggire come ciechi per ogni luogo
su per dirupi e precipizi, mentre le armi e gli uomini precipitavano
gli uni sugli altri".
Molti altri, cui non si apre alcuna via di scampo, avanzano sui
primi bassifondi paludosi, immergendosi in acqua fino a dove possono
rimanesere fuori con la testa o le spalle.
Ci furono alcuni che resi temerari dalla paura, cercarono la fuga
a nuoto, ma poichè non avevano alcuna speranza di superare
quella enorme distanza, venivano inghiottiti dai gorghi , quando
mancavano le forze, oppure, stancatisi inutilmente, riguadagnavano
con enorme fatica i bassifondi, e lì venivano uccisi dove
capitava dai nemici entrati in acqua.
Cartaginesi e celto-liguri guidati dal fratello di Annibale si
scontrano non lontano da Milano con i romani guidati da P. Quintilio
Varo e M. Cornelio Cetego, venendone sconfitto.
La seconda guerra punica si concluse nel 202 a Zama, nel retroterra
tunisino, con la vittoria romana. Restava quindi da riconquistare
la Cisalpina, refrattaria a ritornare sotto il dominio romano
Nel 200 a.C. i Celti, tra cui gli Insubri, oltre a Boi e Liguri,
guidati dal cartaginese Amilcare, che era rimasto in Cisalpina dalla
seconda guerra punica, attaccarono Piacenza colonia romana distruggendola;
la battaglia definitiva ebbe luogo a Cremona, con 35.000 Celti uccisi
e catturati, dai romani guidati dal pretore L. Furio Purpurione..
Nel 197 a.C. Romani e Insubri, dopo che questi ultimi sono stati
sconfitti sul terreno militare (con l'uccisione del generale cartaginese
Amilcare che li guidava), sottoscrivono un foedus aequum , col quale
la capitale insubre rimane autonoma, ma perde il predominio sui
Celti della Padania e s'impegna a fornire aiuti militari.
Molti centri che avevano seguito gli Insubri si arresero ai Romani.
Il trionfo del console C. Cornelio Cetego comprendeva, oltre agli
Insubri e ai Cenomani prigionieri, anche un corteo di coloni cremonesi
e piacentini liberati.
Nel 196 a.C. il console M. Claudio Marcello, figlio del vincitore
di Clastidium, Casteggio, portò l'attacco in territorio insubre,
dirigendosi verso Como, dove gli Insubri avevano posto il loro quartier
generale. Como, già dopo pochi giorni, si arrese ai Romani
con 28 castella.
Nel 194 a.C. gli irriducibili Boi incitarono alla ribellione gli
Insubri, ma nel 195 a.C.furono battuti vicino a Mediolanum dal proconsole
Lucio Valerio Flacco. Fu la fine della confederazione celtica: gli
Insubri e i Cenomani abbandonano i Boi e strinsero un foedus con
Roma, che permise loro di mantenere una certa autonomia.
Nel 191 a.C. vengono definiti nuovi accordi, ricordati in un'orazione
di Cicerone ( Pro Balbo 14, 32), nei quali è presente la
clausola che gli Insubri non potranno ricevere la cittadinanza romana
per non turbare l'ordine sociale celtico.
Storie di Polibio: nel libro II si trova la descrizione entusiastica
delle condizioni economiche di Milano e dell'Insubria. A Milano
vi sono grandiosi edifici nell'area intorno al Cordusio, di probabile
uso pubblico.
L'area insubre non subì alcuna perdita di territorio e venne
accuratamente evitata dalla rete viaria romana. Nessuna strada romana
l'attraversava: la via Postumia, creata nel 148 a.C. per scopi militari,
che univa Genova ad Aquileia, rimase ai margini del territorio insubre.
E la stessa conservazione del tipo di popolamento preromano, sparso,
per vicos (villaggi), esclude un intervento teso a modificare le
strutture territoriali.
Gli Insubri s'impegnarono a fornire contingenti di cavalleria all'esercito romano (auxilia Gallica), rinunciando però ad accampare diritti sulla cittadinanza romana.
La Transpadania subì un lento processo di romanizzazione,
che non si affermò nel modo violento con qui si sviluppò
nelle Marche, contro i Senoni, e in Emilia, contro i Boi, ma fu
piuttosto "una lenta penetrazione pacifica di modelli culturali
ed economici che modificò sostanzialmente la società
indigena" (Tolfo).
La moneta corrente era costituita dalle emissioni monetarie celtiche,
che imitavano la dracma marsigliese, con scritte in leponzio.
Scrive Ermanno Arslan:
"Gli Insubri, anche se non trattati come i Boi, devono accettare
che tutti i popoli dominati a nord (Comensi, Orumbovii) e ad ovest
(libici, salluvii. laevi, marici,vertamocori ecc.:alcuni giunti
nel IV secolo,altri di tradizione piu' antica) accedano all'indipendenza,con
autonomi foedera stipulati con Roma. Nascono così numerosi
'stati satellite' corrispondenti forse alle colonie fittizie dell'89
a.C.
Il territorio insubre è ora molto ridotto, esteso a nord
forse poco sopra l'attuale Monza, tra Ticino ed Adda (od Oglio)
senza giungere a sud al Po,dove sono perduti i territori destinati
a Cremona (se non erano cenomani). Pure questa antica popolazione,
certo disarmata (si spiega l'assenza di corredi con armi per gran
parte di questa fase) si rivelerà elemento trainante culturalmente
ed economicamente nella Transpadania..Gli altri gruppi mantennero
il diritto di portare le armi,segno di formale autonomia politica
e militare, con un preciso riscontro nei corredi funerari, nei quali
il guerriero ha sempre la panoplia (Garlasco presso Pavia). La lettura
delle fonti rivela in questa fase una certa insicurezza da parte
dei romani. Il tracciato della via Postumia aggira a sud l 'Insubria,indicando
forse rispetto del popolo federato ma anche,e forse piu' credibilmente,diffidenza.La
nuova via strategica passa per quanto possibile su territorio romano.
Si è lontani da ogni ipotesi di integrazione. (solo) ...
nell'81 la Transpadana diviene provincia, sede quindi di forze armate,
con possibilità di intervento di Roma, cosa che avviene con
Cesare" (da I Celti, Milano, 1991, pagg. 485-486, Ermanno Arslan,
I Transpadani).
di Rolando Dubini
rolando.dubini@fastwebnet.it
http://guide.supereva.it/musica_celtica_/
http://it.groups.yahoo.com/group/celtegh

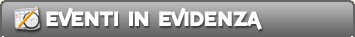

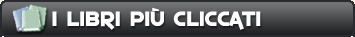
di Michael A. Cremo, Richard L. Thompson2. Archeologia Misterica
di Luc Bürgin3. Archeologia dell'impossibile
di Volterri Roberto4. Archeologia eretica
di Luc Bürgin5. Il libro degli antichi misteri
di Reinhard Habeck6. Rennes-le-Château e il mistero dell'abbazia di Carol
di Roberto Volterri, Alessandro Piana7. Il mistero delle piramidi lombarde
di Vincenzo Di Gregorio8. Le dee viventi
di Marija Gimbutas9. Come ho trovato l'arca di Noè
di Angelo Palego10. Navi e marinai dell'antichità
di Lionel Casson

ARCHEOLOGIA BIBLICA
ECCEZIONALE RITROVAMENTO IN UN TUNNEL SEGRETO IN MESSICOARCHEOLOGIA BIBLICA
CIMITERO DI ANFORE IN DUE NAVI ROMANE NELLE EOLIEARCHEOLOGIA BIBLICA
SCOPERTI VASI DI ARGILLA CRUDI A POMPEIPALEONTOLOGIA
IL GIGANTE DI ATACAMA: UN ALTRO GEOGLIFO CHE SFIDA LA NOSTRA COMPRENSIONE DEL PASSATOARCHEOLOGIA BIBLICA
TROVATA AD ORVIETO LA TESTA DEL DIO DEGLI ETRUSCHIPALEONTOLOGIA
IL MISTERO DELLE TORRI SEGRETE DELL'HIMALAYAARCHEOLOGIA BIBLICA
UNO SCAVO ILLEGALE SCOPRE UN TEMPIO DI THUTMOSE IIIPALEONTOLOGIA
LA BUFALA CHE GESU' FU PADRE E MARITOPALEONTOLOGIA
IL "SEME MAGNETICO" CHE DIEDE VIA ALLA VITA VEGETALE SULLA TERRAPALEONTOLOGIA
TRAPPOLE PER DEMONI SCOPERTE IN INGHILTERRA