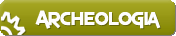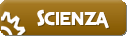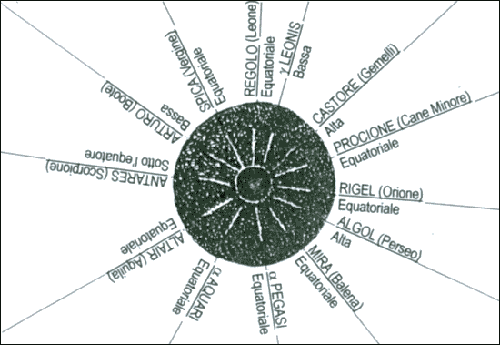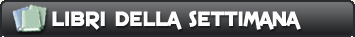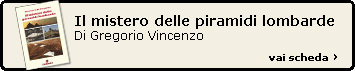Il "Tredesin de Marz" è una pietra cara alla memoria
dei Milanesi: fu tenuta in somma considerazione nell'antichità
ed è stata poi custodita con grande amore, fino ai giorni
nostri.
Questa pietra rotonda, con tredici scanalature radiali e foro centrale,
è oggi collocata al centro della navata, nella chiesa di
S. Maria al Paradiso in Milano. Parte della sua storia è
scritta in latino, sulla lapide di marmo bianco che la incornicia:
"Il 13 marzo del 51° anno del Signore, S. Barnaba Apostolo
nel mentre predicava ai Milanesi il Vangelo di Cristo, non lungi
dalle mura di Via Marina, a Porta Orientale, in questa pietra rotonda
piantò il vessillo della Croce". Il fatto avvenne fuori
della cinta della città, in un luogo dove la cultura latina
non si era ancora imposta ed era ancora molto viva la tradizione
locale, che si richiamava al patrimonio di conoscenze dei Celti.
In questi ultimi anni, la vicenda di S. Barnaba a Milano è
ricordata con qualche imbarazzo dalla critica storica e persino
dalla Chiesa Cattolica che la considera solo, come una pia leggenda.
Sono dubbi che non ci sentiamo di condividere, anche perché
non sono suffragati da studi specifici o da nuova documentazione.
Al contrario, il comportamento di Barnaba è del tutto coerente
con il personaggio descritto nel Nuovo Testamento. Anche l'ambiente
dove si svolge l'episodio (vale a dire la città romanizzata
e i luoghi immediatamente fuori le mura) trova più conferme
che smentite, nelle recenti acquisizioni archeologiche.
Nessuno, comunque, può disconoscere il fascino di questa
"rozza pietra rotonda" ed il senso di mistero che la avvolge;
certamente doveva avere un peculiare significato, perché
fu tenuta sempre in grande stima, anche se sembra realizzata in
modo rozzo e disordinato. è difficile capire perché
sia stata incisa senza un minimo di cura: un'operazione che non
avrebbe neppure richiesto una grande abilità.
Per trovare una spiegazione abbiamo compiuto un'attenta indagine
sulla pietra; l'abbiamo esaminata a lungo, in più occasioni,
da diverse posizioni, sotto differenti angolature di luce, perfino
ad occhi chiusi, sfiorandola con la punta delle dita.
Perché rotonda? Quale significato possono avere i settori,
nei quali sembra divisa? Per qual motivo il foro? A cosa servono
le scanalature? Per quale ragione, i segmenti non sono equidistanti?
Come mai, non escono esattamente dal punto centrale?
La singolare forma e la finitura della pietra suggeriscono una simbologia,
che fu associata ad una sorta di "Calendario Mistico".
Taluni autori collegano la pietra al calendario celtico: "Tredesin,
perché il loro calendario iniziava il tredicesimo giorno".
In questo senso, è lecito pensare che il manufatto possa
essere messo in relazione col cielo stellato, in quanto presso i
Celti, la misura del tempo era strettamente legata all'astronomia.
Lo scrittore latino Marziano Cappella ci descrive la suddivisione
della volta celeste, immaginata dagli auguri etruschi: era divisa
in sedici parti, nelle quali si trovavano le abitazioni delle diverse
divinità. è probabile che la cultura celtica, quantomeno
padana, avesse elementi in comune con quella etrusca ed è
evidente una notevole analogia con la "pietra rotonda",
anche se questa è ripartita in soli tredici settori.
|
|
| Tredesin de Marz: la pietra rotonda, col foro nel centro ed i tredici raggi. |
La forma tonda non deve sorprendere, perché la linea dell'orizzonte
dà la sensazione che la volta celeste sia rotonda: anche
le moderne rappresentazioni, che possiamo trovare su un qualsiasi
atlante di geografia astronomica, sono rotonde e per essere utilizzate
vanno opportunamente ruotate in funzione del giorno e dell'ora.
Se questo era lo scopo della pietra, per meglio prestarsi alla bisogna,
doveva essere ruotata, tenendola appoggiata su un piano passante
per l'equatore celeste, quindi opportunamente inclinato; ma per
girare intorno ad un punto, su un piano pendente, necessitava di
un perno di sostegno e quindi un foro per infilarvela, per evitare
che scivolasse sotto la spinta del suo peso.
E come poteva essere utilizzata, per individuare le stelle? Osservando
a lungo la pietra, non solo si notano vistose asimmetrie, ma s'impara
anche a riconoscere le singole scanalature, una per una: non ce
ne sono due uguali. Queste irregolarità sono state interpretate
come elementi di un'arte rozza: tesi poco convincente. Ribaltando
completamente il ragionamento, vorremmo sostenere che le scanalature
sono state fatte con apposito criterio e lungo studio: ciascuna
di esse potrebbe indicare una specifica stella, o quantomeno il
punto dove il suo meridiano incontrava l'equatore celeste.
Per individuare la posizione di una stella nel cielo non basta conoscere
quest'indicazione, che gli astronomi chiamano "ascensione retta",
è indispensabile sapere anche qual è l'altezza della
stella, vale a dire la distanza angolare rispetto all'equatore celeste.
La pietra fornisce perfino questa indicazione. Basta osservare che
le scanalature non sono tutte perfettamente orientate verso il centro;
in genere, l'estremità a destra tende ad orientarsi verso
l'alto, in modo più o meno accentuato: poche sono le scanalature
si sovrappongono esattamente al raggio geometrico o volgono leggermente
verso il basso.
Se non vogliamo attribuire anche queste irregolarità all'inesperienza
dello scalpellino dobbiamo trovare una ben precisa ragione per tali
anomalie.
Abbiamo pensato di associarle proprio all'altezza delle stelle,
ipotizzando che ciascun astro, del quale si è indicato il
meridiano, si trovi rispettivamente alto, intermedio, basso, oppure
sotto all'equatore celeste, secondo quanto suggerito dalla deviazione
di ciascun'incisione.
La lettura della pietra è più facile a farsi, che
a dirsi; nessun altro strumento sarebbe più idoneo per indicare
le stelle. Ogni incavo segnala la direzione e - nello stesso tempo
- la sua divergenza dal raggio fornisce un'indicazione dell'altezza
sull'equatore. Questo manufatto ha addirittura una prerogativa unica:
le incisioni sono facilmente intelligibili perfino al buio, che
è la situazione ottimale per chi guarda il cielo stellato.
Basta sfiorare la pietra con le dita, mentre l'occhio scruta la
volta celeste.
Il firmamento osservato dai Celti nell'Età del Ferro non
era esattamente quello che oggi possiamo vedere. La diversa inclinazione
dell'asse terrestre permetteva di scorgere un numero maggiore di
stelle nell'emisfero australe; ma se la posizione di ciascun astro
è riferita all'equatore celeste (variato anch'esso per lo
stesso motivo) le coordinate non mutano sostanzialmente: va, comunque,
ricordato che qualche stella è oggi meno appariscente di
quanto lo fosse un tempo, come nel caso di Mira.
Ad ogni riga, incisa sulla pietra, è stato possibile associare
i nomi dei corpi celesti che riteniamo potesse individuare, nonché
loro altezza. Una decina di scanalature è relativa a stelle
particolarmente importanti, tra le più citate nei testi che
trattano dell'astronomia dei Celti; tre indicazioni, invece sembrano
riferirsi ad astri meno vistosi: sono molto vicini all'equatore
e forse erano utili proprio per individuare quest'importante curva
celeste. Nel complesso, la corrispondenza tra le indicazioni e gli
astri, ci sembra più che soddisfacente.
La nostra ipotesi chiarisce una mezza dozzina di quesiti, ai quali
nessuno aveva mai saputo dare una risposta, perché si pretendeva
sempre di vedere nel manufatto solo "una rozza pietra".
Difficile immaginare le più antiche vicissitudini dell'oggetto,
tagliato forse per altre esigenze. Nonostante la presenza di un
foro, nessuno ha mai ipotizzato che potesse trattarsi di una macina
da mulino: che solitamente ha un diametro doppio ed uno spessore
quantomeno triplo. Secondo taluni, la pietra forata ha un valore
particolarissimo, risalente ad antichissime credenze indoeuropee:
il foro si chiama "porta della liberazione", attraverso
la quale l'anima può passare oltre e salvarsi.
La pietra può quindi essere appartenuta ad un primitivo luogo
di sepoltura, anche se non necessariamente ad un'area cimiteriale.
Non è raro il caso di pietre, che poi sono state riutilizzate
per diverse finalità e questo può essere accaduto
anche alla nostra, che era particolarmente idonea ad indicare le
stelle, non solo per la sua forma, ma soprattutto per il foro nel
mezzo.
Difficile ipotizzare a cosa servisse esattamente questa pietra rotonda
con tredici scanalature, ma sostanzialmente poteva avere due valenze:
o fungere da meridiana notturna, oppure rappresentare una mappa
del cielo stellato. Nel primo caso, poteva fornire indicazioni per
la durata di riti notturni; nell'alto, permetteva di orientarsi
meglio nel cielo stellato. In entrambe le eventualità, costituiva
un vero congegno scientifico.
Oggi può sembrare strano, che una pietra possa essere ritenuta
uno strumento astronomico, ma nell'antichità si usavano proprio
manufatti con quest'aspetto e simili dimensioni. Ci riferiamo alle
meridiane portatili: erano in pietra (come il Tredesin) e avevano
forma e scanalature grossolanamente analoghe; anch'esse erano utilizzate
dopo essere state debitamente posizionate. Guardandoli oggi, i segmenti
tracciati sulla loro superficie appaiono disordinati e privi di
significato, mentre corrispondevano a precise posizioni del sole.
Lo stesso - probabilmente - vale anche per il Tredesin, costruito
per indicare la posizione delle stelle, ma oggi considerato solamente
una rozza pietra rotonda.
|
|
| IL TREDESIN, col nome delle stelle che presumibilmente indicava e la loro altezza, rispetto all'equatore celeste. |
1. Lo studio che correla la geometria delle incisioni, con la posizione
d'alcuni astri è disponibile, per chi fosse interessato.
L'impostazione scientifica è abbastanza coerente, ma lo svolgimento
è piuttosto grossolano: si è voluto privilegiare la
correttezza della metodologia, piuttosto che la raffinatezza nei
calcoli.
Uno studio più approfondito sarebbe senz'altro facilmente
realizzabile, in quanto la pietra si può fotografare e misurare
senza difficoltà: I costi tecnici di tale ricerca sono pressoché
nulli; non necessita alcuna autorizzazione; la disponibilità,
da parte della Parrocchia citata, è completa.
Ritengo, invece, più difficile riuscire a costituire un piccolo
gruppo di lavoro, di tecnici con specifiche competenze, quantomeno
in archeologia, astronomia e matematica. Le mie competenze in questi
settori non sono particolarmente approfondite; in archeologia: sono
un dilettante ed autodidatta; quanto all'astronomia: ho letto con
cura i testi di Gaspani e ho verificato con lui alcune documentazioni;
la matematica: la insegno ai licei.
Vedrei con piacere una tale verifica, ma non la ritengo essenziale.
L'articolo proposto trova il suo punto di forza nella metodologia
proposta:
a) prescindere dalle "solite considerazioni": se necessario,
provare a ribaltarle,
b) evitare ipotesi vaghe,
c) una volta formulata un'ipotesi, bisogna tentare di dimostrarla,
con considerazioni il più possibile semplici e chiare.
2. Per orientarsi, nella lettura delle due figure, è necessario
individuare un'asse di riferimento. Suggerirei quello costituito
da due raggi, che sembrano formare un diametro. Uno di essi è
facilmente individuabile sulla foto perché termina con una
discontinuità (tappata con cemento bianco). Ruotando la figura
fino ad avere questo punto di riferimento in basso, ci troviamo
con sei raggi a sinistra e cinque a destra.
Il disegno riproduce una vista azimutale (la foto no) e ha un aspetto
apparentemente diverso dalla fotografia. Per la sua lettura, anche
il disegno va ruotato: il raggio da volgere verso il basso è
diretto verso Spica, mentre quello opposto indica Mira.
Tra Spica e Arturo, i raggi formano una "V", ben individuabile
anche sulla foto. Le scanalature che seguono sono ben differenziate,
separate e pressoché radiali; infatti, abbiamo Antares, che
è poco sopra l'equatore, nonché Altair e altre due
stelle che sono equatoriali.
Dopo Mira, abbiamo un'altra "V", perché Algol è
una stella alta. Seguono Rigel e Procione (equatoriali), un'altra
"V", per Castore che è alta. Infine troviamo una
stella bassa e Regolo, equatoriale.
Questa lettura può essere fatta agevolmente sia sulla foto,
sia sul disegno.
3. Il contenuto dell'articolo è già stato proposto
(in forme diverse) in altre occasioni. Esso costituisce una parte
di un capitolo di "MILANO CELTICA E I SUOI CITTADINI",
dove è prospettato in un contesto storico molto più
ampio. La stesura che qui propongo è adattata a quelle che
ritengo siano le vostre esigenze.
di Giorgio Fumagalli
mfumagalli@infinito.it

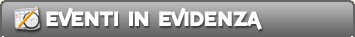

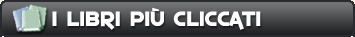
di Michael A. Cremo, Richard L. Thompson2. Archeologia Misterica
di Luc Bürgin3. Archeologia dell'impossibile
di Volterri Roberto4. Archeologia eretica
di Luc Bürgin5. Il libro degli antichi misteri
di Reinhard Habeck6. Rennes-le-Château e il mistero dell'abbazia di Carol
di Roberto Volterri, Alessandro Piana7. Il mistero delle piramidi lombarde
di Vincenzo Di Gregorio8. Le dee viventi
di Marija Gimbutas9. Come ho trovato l'arca di Noè
di Angelo Palego10. Navi e marinai dell'antichità
di Lionel Casson

ARCHEOLOGIA BIBLICA
ECCEZIONALE RITROVAMENTO IN UN TUNNEL SEGRETO IN MESSICOARCHEOLOGIA BIBLICA
CIMITERO DI ANFORE IN DUE NAVI ROMANE NELLE EOLIEARCHEOLOGIA BIBLICA
SCOPERTI VASI DI ARGILLA CRUDI A POMPEIPALEONTOLOGIA
IL GIGANTE DI ATACAMA: UN ALTRO GEOGLIFO CHE SFIDA LA NOSTRA COMPRENSIONE DEL PASSATOARCHEOLOGIA BIBLICA
TROVATA AD ORVIETO LA TESTA DEL DIO DEGLI ETRUSCHIPALEONTOLOGIA
IL MISTERO DELLE TORRI SEGRETE DELL'HIMALAYAARCHEOLOGIA BIBLICA
UNO SCAVO ILLEGALE SCOPRE UN TEMPIO DI THUTMOSE IIIPALEONTOLOGIA
LA BUFALA CHE GESU' FU PADRE E MARITOPALEONTOLOGIA
IL "SEME MAGNETICO" CHE DIEDE VIA ALLA VITA VEGETALE SULLA TERRAPALEONTOLOGIA
TRAPPOLE PER DEMONI SCOPERTE IN INGHILTERRA