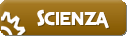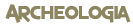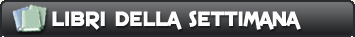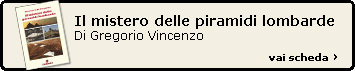Una nave che non c'è, tanti frammenti spostati incessantemente dalle onde, un gabbiano, solitario, che osserva tutto, appollaiato sul muretto dirimpetto al mare.
Sembrano gli ingredienti di un romanzo giallo o di una delle tante leggende del Mediterraneo.
Sono invece la materia quotidiana degli archeologi dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Coimbra, dove lavora già da alcuni anni, nonostante la giovane età, l'archeologa molfettese Alessia Amato, dottore di ricerca in di Archeologia Navale Islamica.
Ricostruiamo il quadro: una nave ha fatto naufragio, in età augustea, trasportando vasi di terracotta pieni di olio d'oliva dal sud del Portogallo verso la Britannia, attuale Gran Bretagna.
Ma la nave non c'è. Dunque?
Facciamo un passo indietro: sulla base di alcune segnalazioni di un pescatore del luogo, gli archeologi dell'Università di Coimbra iniziano alcuni anni fa ad indagare il tratto di mare di fronte alla città di Peniche, nel sud ovest del Portogallo.
Le segnalazioni risultano veritiere: si rinvengono più di 5000 frammenti di vasi di terracotta del tipo "Haltern 70", utilizzati per il trasporto dell'olio ed altri afferenti, invece, ad un'altra tipologia di vaso, la "sigillata italica". Ed è quest'ultimo indizio che fa collocare la datazione del naufragio in età augustea (25 a.C.-15 d.C.), restringendo le iniziali datazioni.
Inoltre, dalla quantità di frammenti rinvenuti, è possibile anche risalire a qualche caratteristica della nave "fantasma": una nave "leggera", quindici tonnellate, frantumatasi sulle pericolose rocce affioranti nel tratto di mare di fronte ad una costa impervia come solo le coste oceaniche sanno essere.
I frammenti, unici e preziosi testimoni del naufragio, vengono così recuperati, ripuliti e "desalinizzati": operazione lenta, paziente e delicata, per ricomporre il disegno, la storia, la vita che c'era dietro e dentro quelle anfore spezzate. E' questo che rende affascinante il lavoro degli archeologi in tutto il mondo, qualunque civiltà essi studino: mettere insieme il puzzle, tessera dopo tessera, sino a configurare il quadro originario.
Ma il puzzle, sott'acqua, è ancora più difficile da ricostruire. Le correnti spostano la sabbia continuamente, con essa i frammenti dei vasi e anche i riferimenti che gli archeologi configgono per fissare la posizione di un reperto.
Si lavora a testa in giù, per smuovere l'acqua il meno possibile, perché nulla vada perso, nessun dettaglio. Ogni piccolo particolare può spostare al di qua o al di là il cursore sulla linea del tempo o raccontarci di qualcuno che in tempi passati, forse poco dopo il naufragio, sapendo di quel tesoro sepolto dalle acque, è andato "a testa in giù" a grattare le preziose resine che rivestivano i vasi di terracotta dall'interno per ricavarne materia da riutilizzare. I segni da lui lasciati sono evidenti e fa un certo effetto vederli, nitidi, su un frammento recuperato.
Poi il lavoro del puzzle si ripete, e si ricompone, disegnandola, un'anfora a partire da due soli pezzi che ne raccontano la forma e il volume originario. Affascinante.
Ad un profano della materia può sembrare quantomeno strano, o curioso, questo lavoro di cesello, lento, delicato, difficile. Solo una passione innata, come quella di Alessia Amato e dei ricercatori della sua equipe, può spiegare la caparbietà nel voler "sapere" cosa è successo in quel tratto di mare, oltre le Colonne d'Ercole dove, si sa, per i mortali è vietato andare.
Gli scavi sono terminati nel 2006, le indagini un anno dopo.






di Michael A. Cremo, Richard L. Thompson2. Archeologia Misterica
di Luc Bürgin3. Archeologia dell'impossibile
di Volterri Roberto4. Archeologia eretica
di Luc Bürgin5. Il libro degli antichi misteri
di Reinhard Habeck6. Rennes-le-Château e il mistero dell'abbazia di Carol
di Roberto Volterri, Alessandro Piana7. Il mistero delle piramidi lombarde
di Vincenzo Di Gregorio8. Le dee viventi
di Marija Gimbutas9. Come ho trovato l'arca di Noè
di Angelo Palego10. Navi e marinai dell'antichità
di Lionel Casson

ARCHEOLOGIA BIBLICA
ECCEZIONALE RITROVAMENTO IN UN TUNNEL SEGRETO IN MESSICOARCHEOLOGIA BIBLICA
CIMITERO DI ANFORE IN DUE NAVI ROMANE NELLE EOLIEARCHEOLOGIA BIBLICA
SCOPERTI VASI DI ARGILLA CRUDI A POMPEIPALEONTOLOGIA
IL GIGANTE DI ATACAMA: UN ALTRO GEOGLIFO CHE SFIDA LA NOSTRA COMPRENSIONE DEL PASSATOARCHEOLOGIA BIBLICA
TROVATA AD ORVIETO LA TESTA DEL DIO DEGLI ETRUSCHIPALEONTOLOGIA
IL MISTERO DELLE TORRI SEGRETE DELL'HIMALAYAARCHEOLOGIA BIBLICA
UNO SCAVO ILLEGALE SCOPRE UN TEMPIO DI THUTMOSE IIIPALEONTOLOGIA
LA BUFALA CHE GESU' FU PADRE E MARITOPALEONTOLOGIA
IL "SEME MAGNETICO" CHE DIEDE VIA ALLA VITA VEGETALE SULLA TERRAPALEONTOLOGIA
TRAPPOLE PER DEMONI SCOPERTE IN INGHILTERRA